Una pietanza come un rito, che nasce dai paesi del bacino del Mediterraneo e conquista tutto il mondo
Che si tratti di asparagi verdi, bianchi o selvatici, impariamo come destreggiarci al meglio nella scelta del vino da abbinare a tavola

Qualche tempo fa vi abbiamo già parlato in modo approfondito degli asparagi: ricorderete bene che si tratta di un ortaggio di cui esistono specie diverse, da quelli coltivati a quelli selvatici, ma oggi siamo qui per scoprire un altro aspetto, ovvero come abbinare al meglio gli asparagi al giusto vino in tavola in base alla tipologia e agli altri ingredienti delle ricette.
L’asparago è definito pianta officinale, cioè medicinale (ovvero contiene sostanze curative, medicamentose) per le sue proprietà salutistiche, quali l’ottimo apporto in Sali minerali e vitamine, la funzione diuretica per l’elevato contenuto di potassio e azoto, la stimolazione della peristalsi intestinale per il suo contenuto di fibre.
Di regola, agli asparagi non si dovrebbe abbinare alcun vino quando mangiati da soli (come per i carciofi, le cicorie, gli spinaci crudi, i sedani, le verze, radicchio di Treviso, ecc.) in quanto caratterizzati da una netta tendenza amarognola, conferita per l’asparago dall’ aminoacido asparagina (certamente non tale però da impedire di mangiarne, come accade per esempio con le mandorle amare). La tendenza amarognola (come anche la sapidità e la tendenza acida) di un cibo può essere considerata una sensazione di durezza gustativa, la cui percezione tende a presentarsi con note di aggressività più o meno accentuate. Il vino scelto in abbinamento deve avere perciò caratteristiche opposte di morbidezza, capace di attenuare (difficilmente smorzare) la sensazione di durezza, attuando quindi un abbinamento cibo-vino per contrapposizione. Se anche il vino scelto dovesse avere un nota amarognola accentuata, si otterrebbe uno sgradevole rafforzamento della sensazione di durezza collegata all’asparago, con un risultato finale talmente poco armonico da far decidere di bere solo il vino o mangiare solo gli asparagi e bevendo soltanto acqua.
Nel caso degli asparagi consumati da soli, con condimento semplice di buon olio evo e pochissimo sale (meglio se messo in cottura e comunque con parsimonia), potremmo trovarci nel piatto anche degli asparagi selvatici con una notevole tendenza amarognola, oppure verdi con minore amarognolo e sentore minerale, o ancora bianchi con un amaro che scompare a favore di una tendenza dolce, data dall’imbianchimento e quindi dalla scomparsa della clorofilla che anche di per sé è amarognola, opteremo comunque verso vini bianchi, secchi e abbastanza morbidi, ovviamente con una morbidezza che sarà notevole per i selvatici, minore per i verdi e per i bianchi, con una nota acida che sarà bassissima per i primi, un po’ più alta per i secondi e decisa per i terzi.
In termini pratici, senza entrare nel merito del vitigno usato, questo vuol dire che escluderemo dal condimento sempre l’aceto, in presenza del quale il vino deve essere abolito per l’eccessiva durezza dell’acido acetico, e giocheremo sull’età del vino, abbinando bianchi molto giovani ( 6 mesi dalla vendemmia) per gli asparagi bianchi (acidità ben percepita, in contrasto con la tendenza dolce di questi), bianchi giovani (1 anno dalla vendemmia) per i verdi (acidità minore per la maturazione del vino in bottiglia, con aumento della morbidezza a discapito dell’acidità), vini bianchi d’età superiore a 1 anno e spostati verso i 2 anni per quelli selvatici (deciso aumento della morbidezza per diminuzione dell’acidità).
Va detto però che difficilmente gli asparagi, di qualunque tipo siano, vengono consumati “semplicemente da soli”, per cui sposeremo l’assunto per il quale il vino per le verdure amarognole si abbina alla pietanza che le verdure accompagnano o nella quale sono stati incorporati.
Molti gourmet, come detto, consigliano di non abbinare vino agli asparagi ma solo acqua, ma va detto che ciò vale quando ci si trova di fronte a soli asparagi conditi in modo semplice e senza acidi (limone, aceti, misture tra questi e olio), oppure a pietanze nelle quali l’asparago è appena coperto dagli altri elementi, avendo voluto in casi simili far volutamente sentire il sapore erbaceo e amarognolo dell’asparago. Ma l’abbinamento vino – asparagi non è impossibile in quanto quest’ortaggio (presente sulle nostre tavole di stagione da aprile a giugno) non viene consumato solo “puro”, ma viene spesso cucinato abbinandovi uova, burro, formaggio, prosciutto e altri salumi non troppo sapidi perché anche il sale aumenta la percezione di durezza dovuta all’amarognolo), nonché salse non acide, come panna e simili, nei quali praticamente la tendenza amarognola del vegetale si disperde, divenendo appena percettibile.
Uova, burro, formaggio e grasso dei salumi conferiscono alla preparazione contenente asparagi sensazioni di tendenza dolce (non da zuccheri, per cui non “dolcezza”), grassezza (il tuorlo d’uovo, il burro, il formaggio contengono molti grassi) per cui abbineremo in via generale un vino bianco giovane, con colore classico giallo verdolino o al massimo giallo paglierino, fermo o meglio ancora frizzante (possibilmente non con CO₂ addizionata ma da fermentazione) in modo da stemperare tendenza dolce e grassezza con l’acidità propria del vino bianco giovane, meglio ancora se da CO₂, profumati per bilanciare gli odori di erbe aromatiche/spezie usate nella preparazione (nei bianchi i sentori olfattivi possono essere di frutta a polpa bianca come pesca, albicocca, pera, mela, mandorla dolce, ecc), abbastanza morbidi (grazie a glicerina e alcol),per contrastare la tendenza amarognola degli asparagi; dico “abbastanza” perché la morbidezza non è caratteristica di vini giovani, specialmente bianchi, ma di vini che si bevono dopo un anno dalla vendemmia, quindi più strutturati grazie alla maturazione in legno o in acciaio o nella stessa bottiglia).
Note bibliografiche
- AA.VV., Merceologia degli alimenti, Ed. AIS
- AA.VV., Tecnica dell’abbinamento cibo – vino, Ed. AIS
- Falavigna – Palumbo, La coltura dell’asparago, Edagricole
- V. Forte, Nuovo dizionario tecnico di agricoltura, Edagricole








































































































































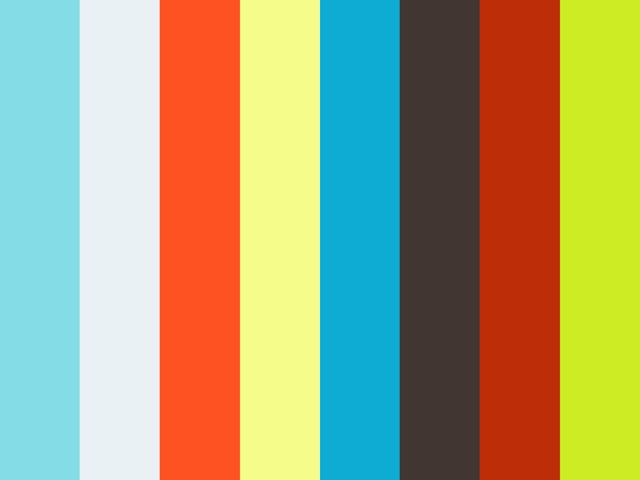
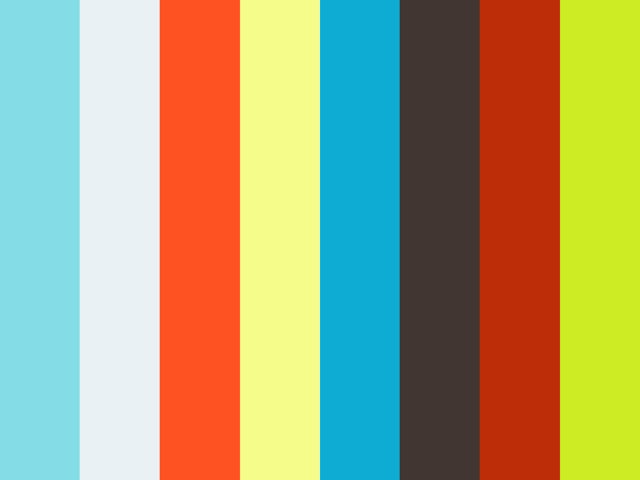
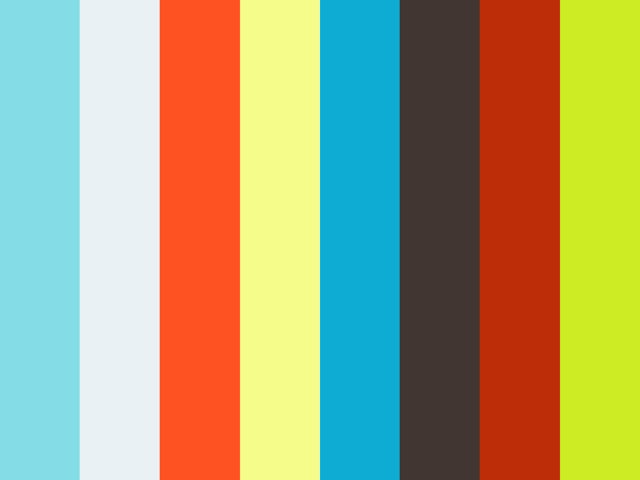
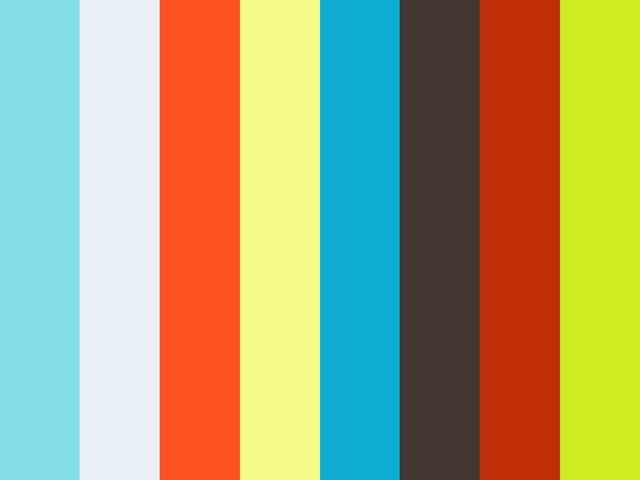
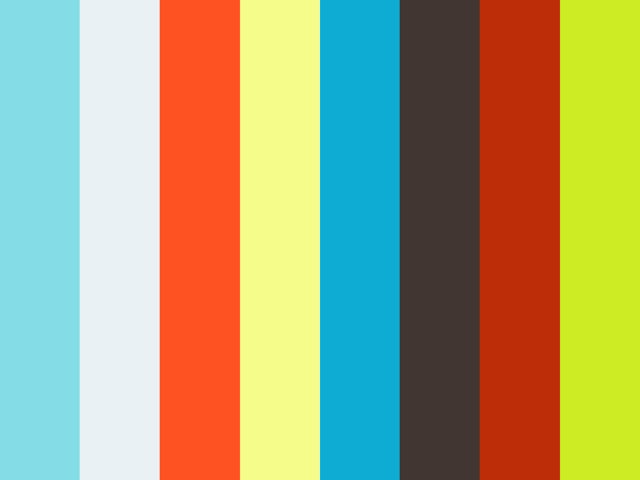
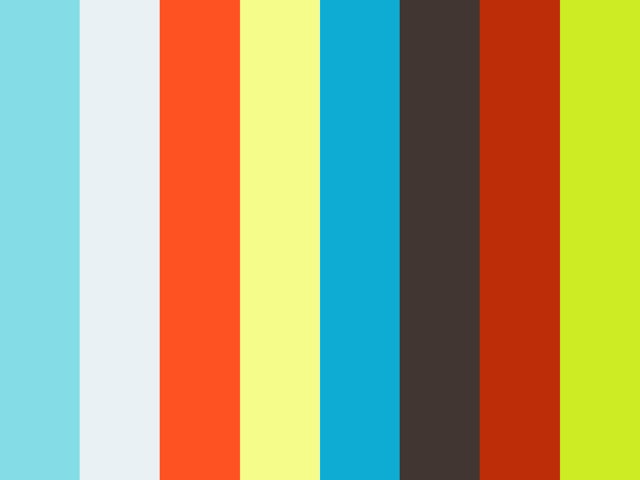

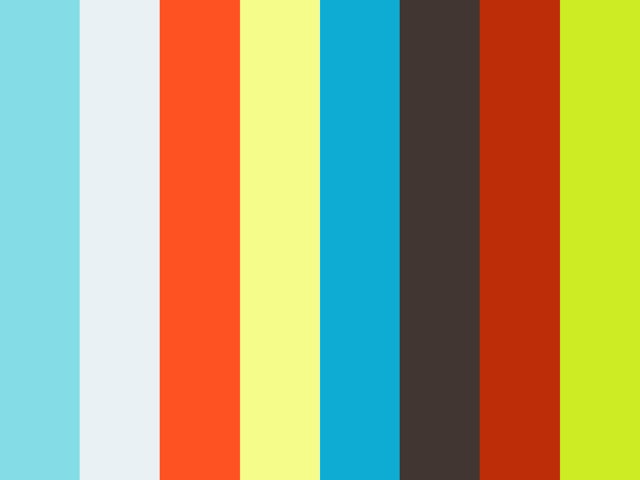

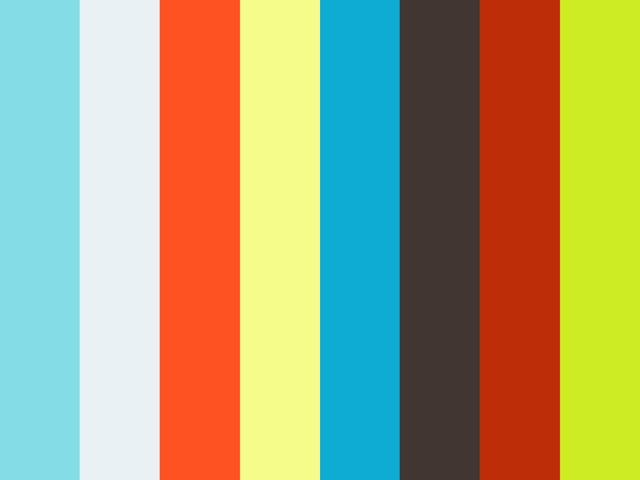
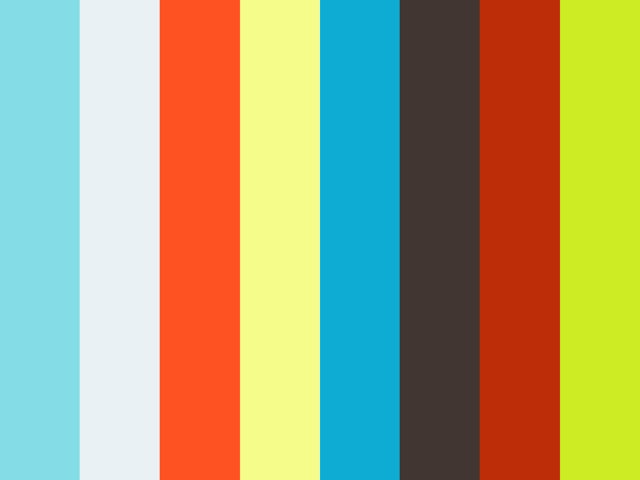
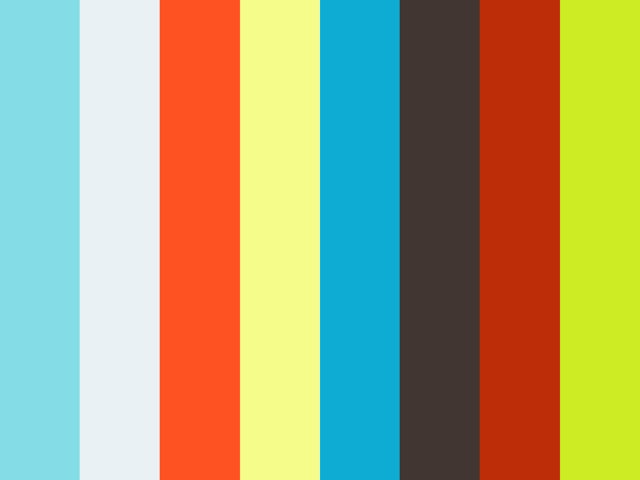
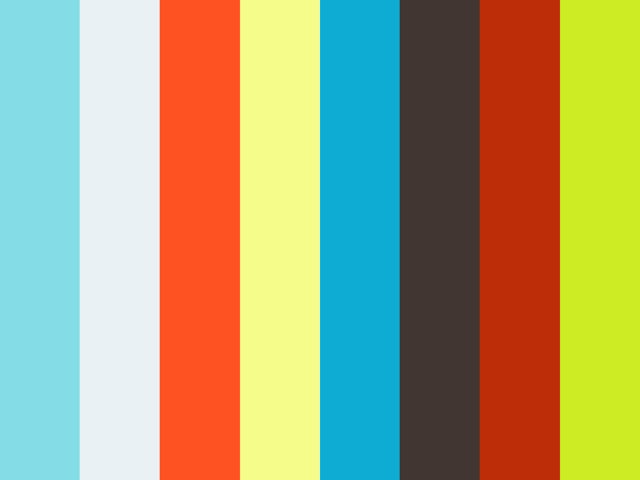
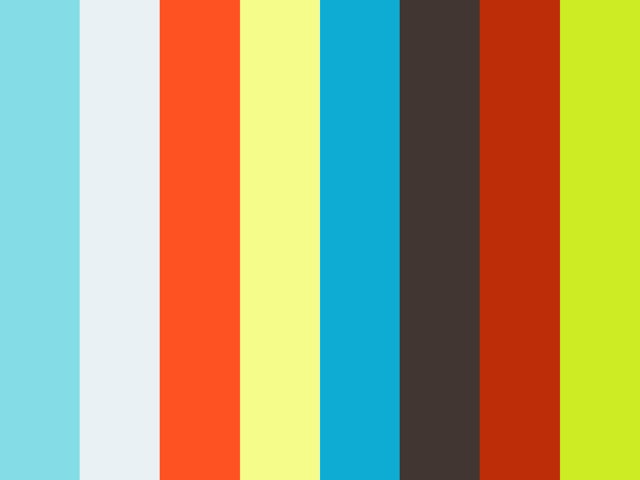
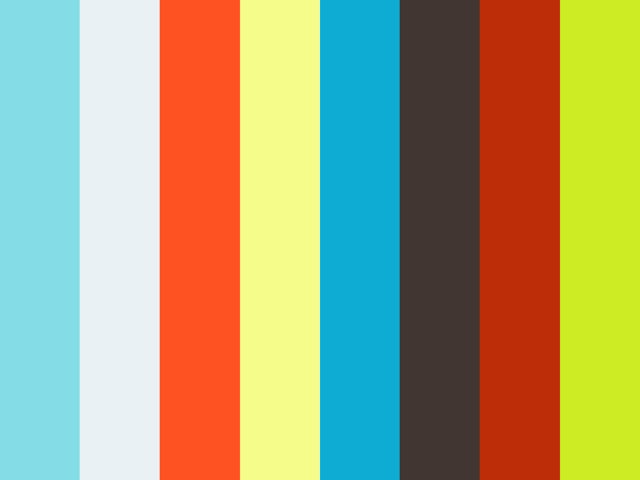
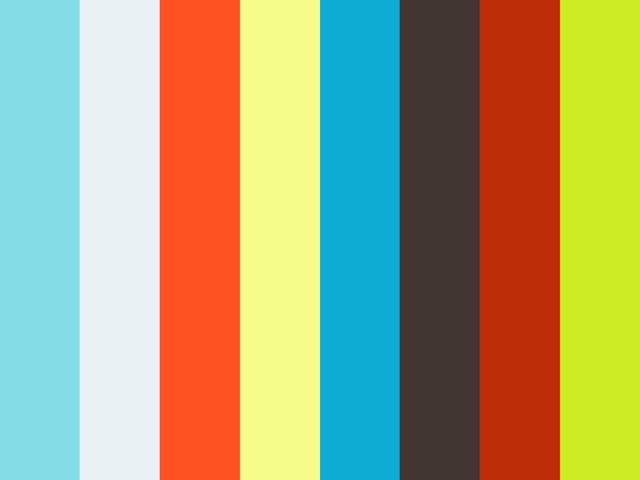
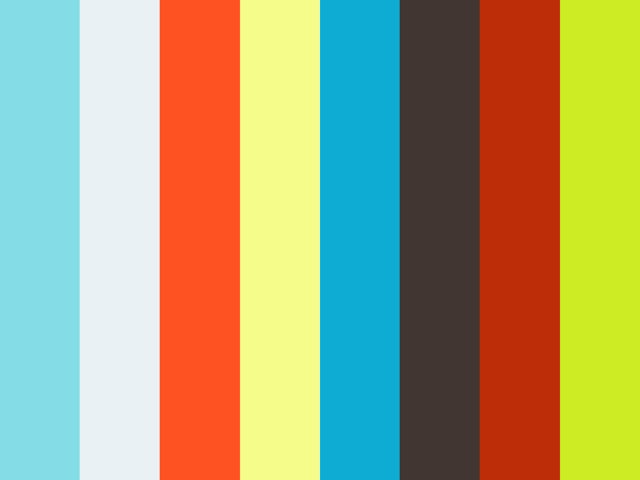





0 Commenti