Una ricerca fa luce sulle problematiche degli esercizi che hanno reso la pietanza turca famosa in tutto il mondo
Non solo cuore, vasi sanguigni e reni: consumare alte quantità di sale cambia anche l'umore e il modo in cui l'organismo risponde allo stress

Cum grano salis: dal senso letterale a quello figurato sale e buon senso sono strettamente correlati sia che ci si riferisca alla coscienza e al sentimento che più specificamente alla salute fisica.
E proprio il sale – come ingrediente a tavola - va utilizzato con buon senso, in modo assennato perché come ormai ben noto, il consumo eccessivo oltre quelle che sono le dosi giornaliere raccomandate rappresenta un potenziale pericolo per la salute e il benessere dell’organismo (aumento della pressione sanguigna e conseguente aumento del rischio di malattie cardio-vascolari come ictus e infarto).
Ricordiamo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda di consumare meno di 5 grammi di sale al giorno, comprendendo in questa quantità sia quello naturalmente presente negli alimenti che quello aggiunto. A fronte delle linee guida, tuttavia, l’ultimo report dell’OMS sul consumo giornaliero mondiale lancia l’allarme rilevando, nella popolazione adulta, un consumo medio preoccupante pari a 10,8 grammi, più del doppio del valore suggerito.
Recenti studi a livello internazionale hanno messo in luce i possibili rischi anche a livello emotivo e psicologico dimostrando che l’eccesso di sale nella dieta può costare caro anche alla salute mentale; in particolare si inizia a studiare il legame tra l’assunzione di sale e l’aumento dei livelli di stress.
Uno studio, pubblicato nel novembre 2022 sul Science Daily, condotto dai ricercatori dell’Università di Edimburgo su una popolazione di topi maschi adulti per un periodo compreso tra le due e le otto settimane cui è stata somministrata una dieta ricca di sale (con una proporzione uguale a quella assunta dagli umani), ha analizzato i campioni di sangue e riscontrato che i livelli del cortisolo, l’ormone dello stress, erano tanto più alti in quegli animali che avevano assunto più sale per un arco di tempo più lungo rispetto al gruppo cosiddetto di controllo. La quantità di cortisolo, inoltre, era più elevata sia in condizioni di “riposo” che in condizioni di stress indotto con valori fino a più 75%.
La condizione fisiologica di stress, dunque, è risultata sempre attivata a prescindere dalle condizioni ambientali; questo significa che la risposta dei topi allo stress era sempre “pronta” facendoli stare in condizione di continua allerta. Se si considera che gli esseri umani sono normalmente sottoposti a molteplici fattori e fonti contemporanei di stress, risulta plausibile che la risposta possa essere simile a quanto rilevato nei topi con un livello “alterato” dell’ormone dello stress.
Questo ed altri studi stanno sempre più evidenziando il legame tra consumo di sale e deterioramento cognitivo che avviene per l’iperattivazione di alcuni specifici geni (come dimostra lo studio di Giuseppe Faraco, professore di neuroscienza presso il Weill Cornell Medicine). Gli studi sui topi con una alimentazione ricca di sale continuano con nuovi protocolli di analisi che hanno l’obiettivo di osservare e registrare come l’aumento dell’assunzione di sale e dei relativi livelli di ormone dello stress si manifestino in comportamenti tipici caratterizzati da aggressività e condotte ansiose.
Lo studioso Lee Gilman, professore di neuroscienze comportamentali presso la Kent State University in Ohio, già attivo in questo settore di studi, ha rilevato che l’assunzione di sale influisce su un fenomeno noto come generalizzazione della paura contestuale. Il fenomeno si verifica quando le risposte di paura condizionate, generate in risposta a minacce sperimentate, vengono memorizzate e successivamente estese anche a stimoli considerati sicuri. Questo è considerato un sintomo caratteristico primario dei disturbi legati all’ansia generalizzata, confermando la tesi sulla relazione tra eccesso di sale e stati patologici dell’umore.
Sebbene gli studi inizino a tracciare nuove concrete vie per la comprensione degli effetti di una dieta ricca di sale sul cervello e sul suo funzionamento, la ricerca comportamentale deve proseguire in termini qualitativi e quantitativi anche nel lungo periodo per poter tradurre scientificamente gli esiti dal campo animale, su cui sono condotti, a quello umano senza tralasciare le ovvie differenze nelle risposte agli stimoli (pratici e psicologici).
Intanto, sia le organizzazioni internazionali che gli scienziati a vario titolo si fanno promotori di campagne educative sull’uso consapevole di sale nell’alimentazione quotidiana, con l’auspicio che i consumatori imparino a dosare il consumo di sale per beneficiare delle sue proprietà, del suo apporto in termini di sapore al cibo senza per questo diventare potenzialmente pericoloso e dannoso per la salute fisica e mentale.
Non in ultimo, adeguate politiche di salute pubblica dovrebbero incentivare l’industria alimentare a ridurre l’aggiunta di sale in alimenti e prodotti conservati e trasformati. Per una alimentazione sana e corretta è importante imparare a considerare accanto al contenuto calorico e all’apporto zuccherino degli alimenti, anche il contenuto di sale.
Photo made in AI
Scritto da Viviana Di Salvo
Laureata in lettere con indirizzo storico geografico, affina la sua passione per il territorio e la cultura attraverso l’esperienza come autrice televisiva (Rai e TV2000). Successivamente “prestata” anche al settore della tutela e promozione della salute (collabora con il Ministero della Salute dal 2013), coltiva la passione per la cultura gastronomica, le tradizioni e il buon cibo con un occhio sempre attento al territorio e alle sue specificità antropologiche e ambientali.






































































































































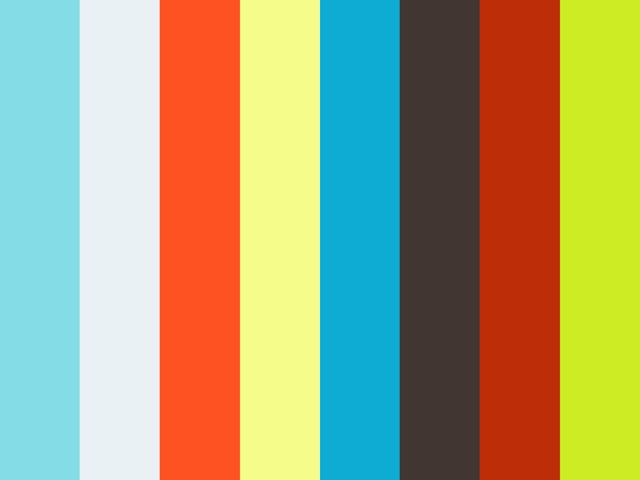
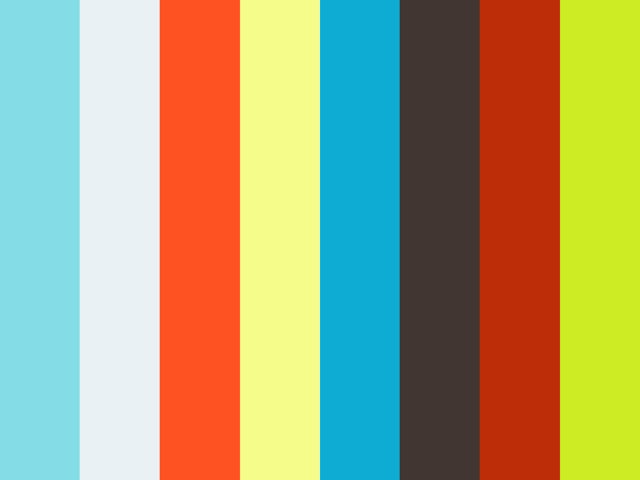
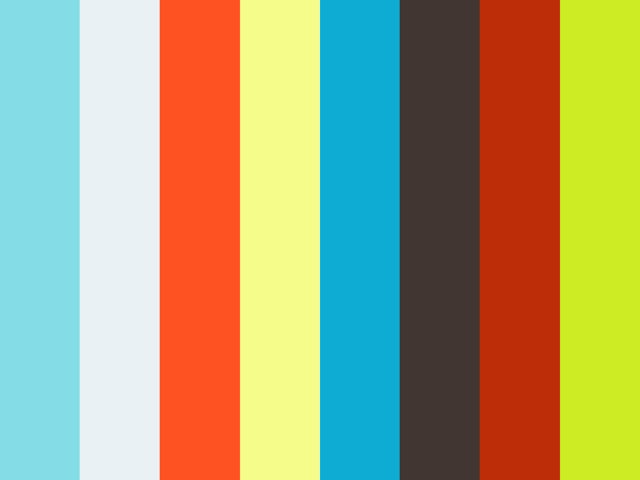
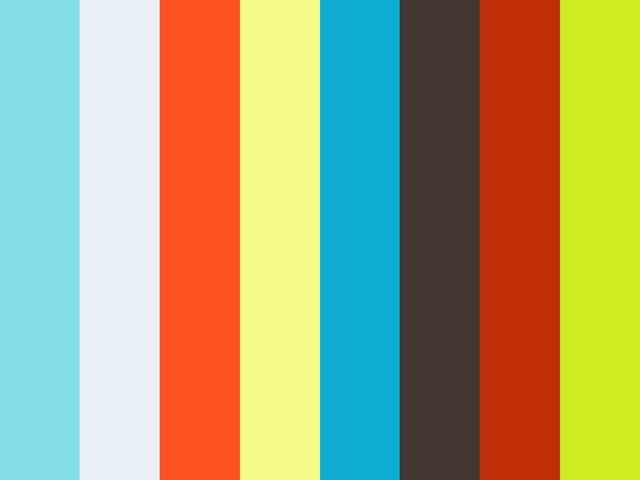
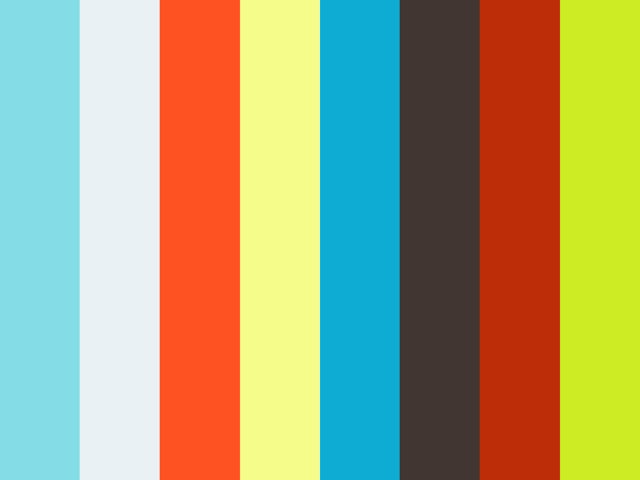
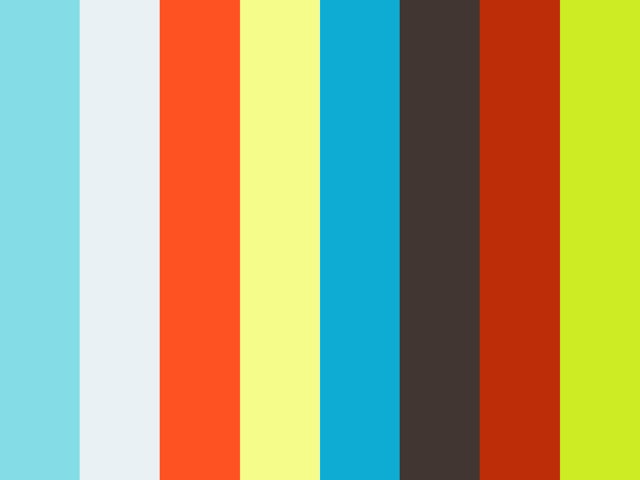

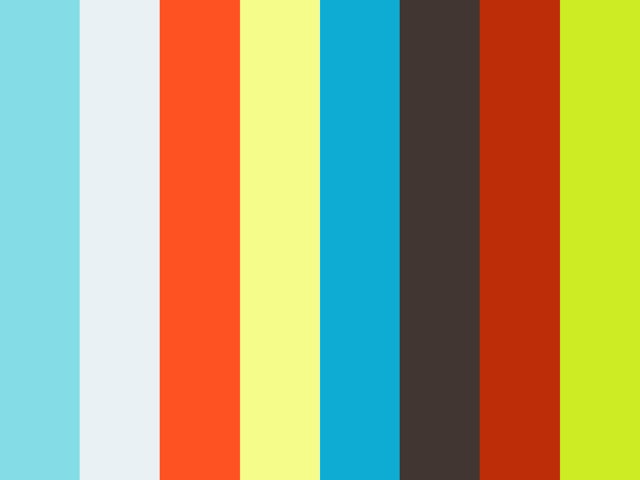

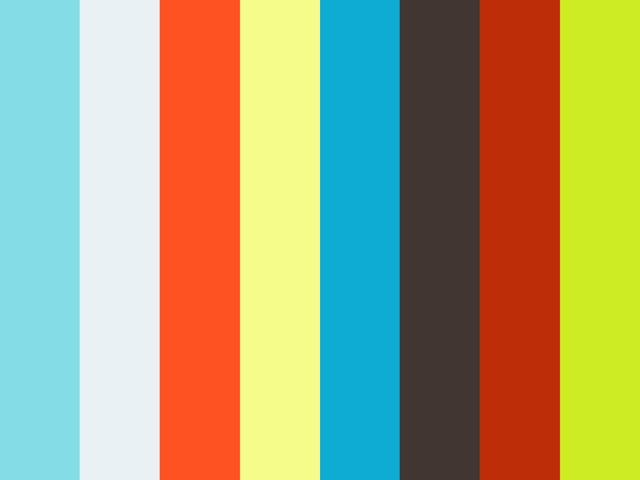
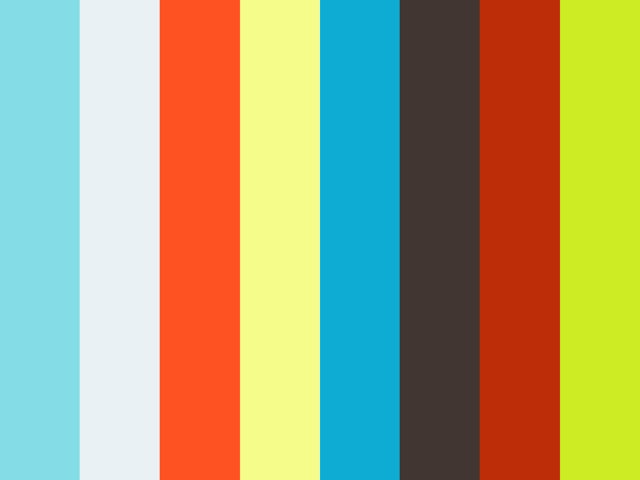
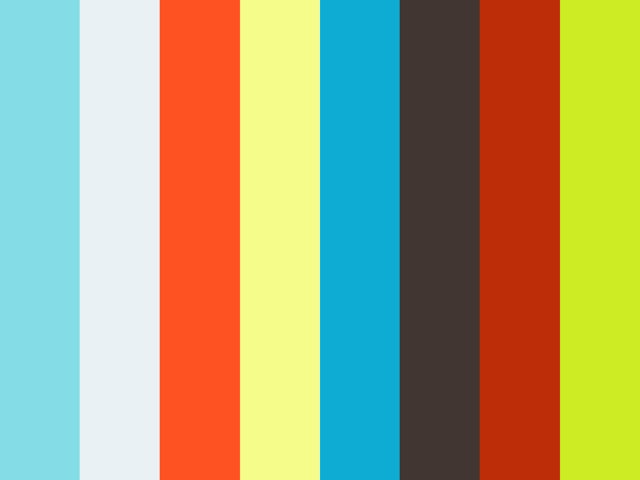
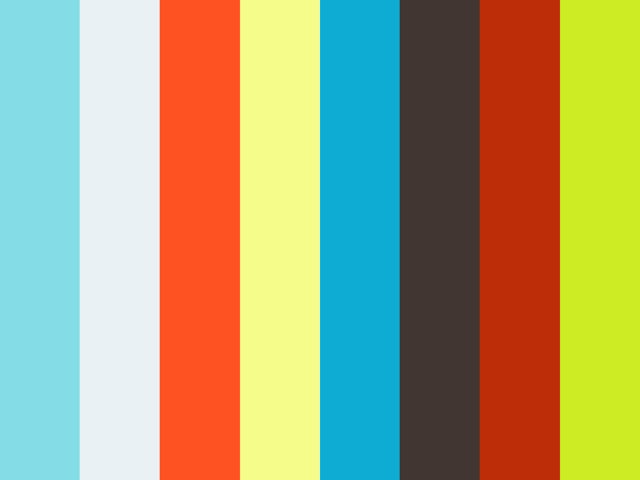
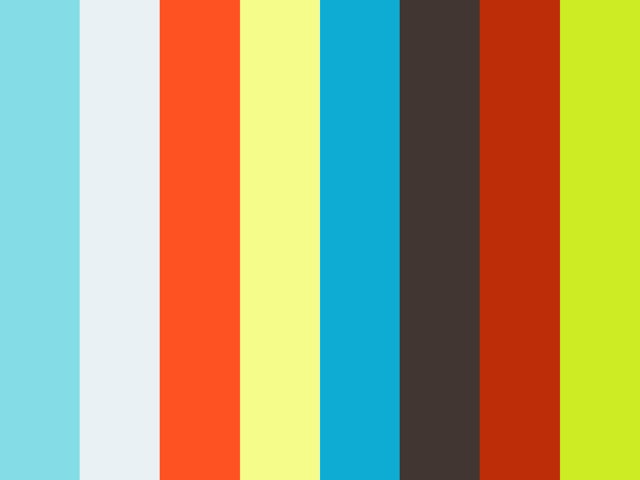
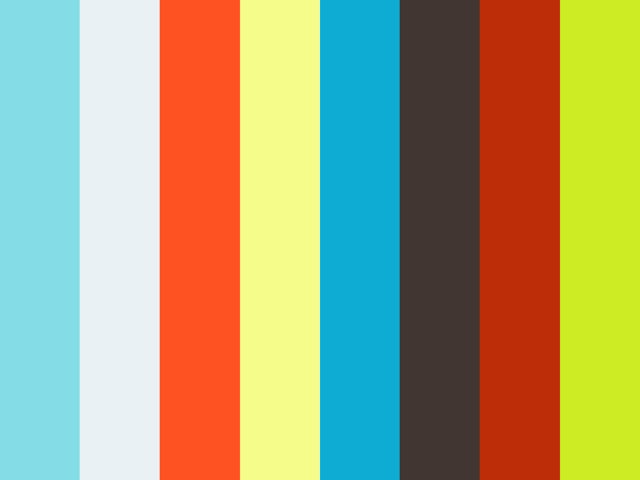
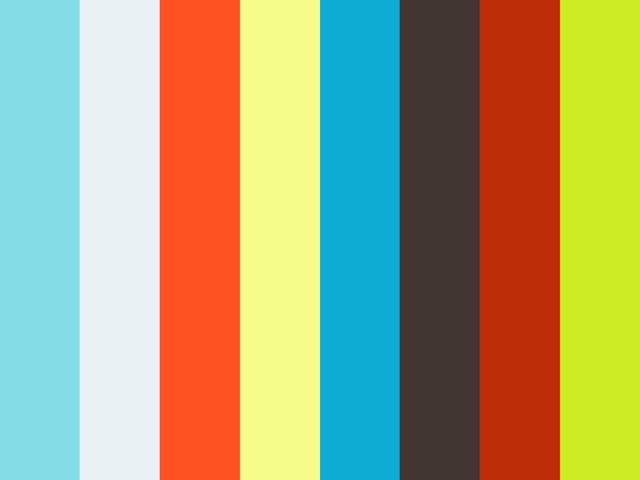
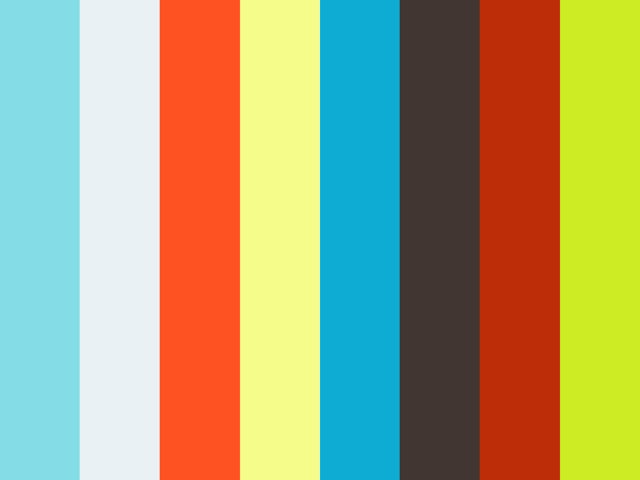






0 Commenti