Quattro formaggi francesi dall’assaggio imperdibile
Sulla nascita della bilancia e sull'applicazione delle moderne unità di misura in cucina

“Cucinare bene” si rivela spesso come una precisa operazione chimico-fisica: per questo, in alcuni casi la differenza tra una cena favolosa o insulsa può dipendere anche da un semplice cucchiaino di ingrediente in più o in meno (soprattutto se si parla di pasticceria… ma non solo). Le ricette sono infatti nate proprio nel tentativo di rendere i piatti il più possibile riproducibili, ovvero per far sì che una molteplicità di soggetti riuscissero a ottenere (quasi) il medesimo risultato.
E’ proprio da questo incipit che prendiamo spunto per soffermarci sull’importanza degli strumenti di misurazione in cucina, in primis la bilancia, dal momento che la sua invenzione e diffusione ha rappresentato una tappa davvero significativa per l’evoluzione dell’umanità intera.
Potremmo infatti considerarla uno dei simboli del passaggio da una civiltà primitiva - dove ogni singola famiglia viveva a spese della natura, utilizzando le risorse disponibili fino all'esaurimento e poi spostandosi in nuovi luoghi quando queste venivano a mancare – a una civiltà evoluta, contraddistinta da flussi sociali, politici ed economici con un proprio ordine. Ma soprattutto con nuove esigenze di scambio, dal momento che, da un certo punto in poi, la pratica primordiale del baratto non si è più dimostrata sufficiente a garantire l’equità per entrambe le parti.
Per queste motivazioni, l’introduzione della bilancia e delle operazioni di pesatura a livello storico non è databile, così come sembra non esisterne un vero e proprio “inventore”: questa evoluzione è considerata una successione naturale delle più primordiali tecniche di conta e misurazione, che in ciascuna area geografica ha conosciuto tempi di sviluppo differenti, in dipendenza del livello civile, culturale ed economico raggiunto da ciascun popolo con le sue peculiarità.
Non a caso, questi stessi molteplici popoli esistenti sul nostro pianeta attribuiscono ciascuno l’invenzione della bilancia a divinità o personaggi della mitologia: per gli Egizi fu il Dio Thot, per gli Ebrei furono Caino e Mosè, per i Greci Ermes, per i Romani Mercurio, e per i Cinesi il filosofo Lyng-Lung.
Anche in diversi passi del Corano si accenna ad una bilancia – destinata a “pesare le azioni umane”: questa, secondo i commercianti musulmani, sarebbe stata portata dall’arcangelo Michele a Noè (attorno al 2400 a.C.) affinché la tramandasse ai suoi nuovi discenti. Non a caso, la bilancia (in particolare quella a bracci) è tutt’ora uno dei più tradizionali simboli di giustizia; nelle rappresentazioni statuarie è sorretta spesso da una donna, personificazione della Giustizia. E anche il fatto stesso che la bilancia sia compresa fra i segni dello zodiaco (Libra), basta a provare che essa è conosciuta fin dalla più remota antichità.
Una volta che la maggior parte dei popoli ebbe adottato l’uso della bilancia, intorno al XVIII secolo si iniziò a sentire sempre più vivamente il bisogno di standardizzare le unità di misura. A quei tempi si parlavano infatti “lingue diverse” da quelle attuali: ad esempio, i terreni si misuravano in base alla quantità di grano utilizzato per la loro semina, in modo da poterne stimare più facilmente il valore. Mentre la compravendita del pane mostrava invece diverse difficoltà, e in diversi luoghi fu tradizione per secoli lo stabilire un prezzo fisso per ogni pane, facendo variare il suo “peso” in relazione al prezzo al quale era stata acquistata la farina.
Ad esempio, nel XIV secolo a Milano venne stabilita una corrispondenza esatta tra unità di volume e unità di peso per le farine, cioè uno staio di farina di grano (per il pane bianco) era pari a 16,5 libbre mentre uno staio di farina di segale e miglio (per il pane di mistura) era di 15 libbre.
Per questi ultimi, ognuno del valore di un denaro, la proporzione era molto semplice: se uno staio di farina di segale e miglio valeva 60 denari, anche 15 libbre di pane di mistura dovevano valere 60 denari e contenere 60 pani da un denaro, perciò ogni pane doveva pesare 7 once; se uno staio di farina valeva 48 denari, 15 libbre di pane dovevano valere 48 denari e ogni pane da un denaro doveva pesare 8,75 once. Un sistema di certo astuto ma che restava comunque complesso da applicare.
Sulle unità di misura in uso in Italia nel corso dei secoli, tante testimonianze giungono dagli scritti lasciatici in eredità dai mercanti di un tempo, che erano i primi a doversi districare giornalmente nella stima dei prezzi e nelle conversioni tra unità di misura diverse. Il tempo ha fatto sì che giungessero a noi sia piccole guide manoscritte, che vere opere complete e dettagliate, affiancate da testi di natura matematica, Il Libro di divisamenti di paesi e di misuri di mercatanzie e d'altre cose bisognevoli di sapere a mercatanti di diverse parti del mondo di Francesco Balducci Pegolotti, redatto nel XIV secolo, è ritenuto una delle fonti più antiche.
Fu solo nella seconda metà del Seicento che in Francia qualcuno iniziò a pensare concretamente ad un sistema di misura che potesse diventare universale: parliamo dell’abate-scienziato lionese Gabriel Mouton, che grazie al suo grande amore per l’astronomia e la matematica, nel 1670 scrisse le Observationes diametrorum solis et lunae apparentium, e per la prima volta proponeva al mondo uno standard di misurazione basato sulla circonferenza della Terra, ai tempi divisa in decimi. Nonostante i valori assegnati da Mouton si rivelarono in seguito non esatti (causa la stima errata delle dimensioni terrestri), fu proprio costui che influenzò gli eventi, sempre francesi, legati all’adozione del sistema metrico decimale.
Ben centoventi anni dopo, nel 1790, Talleyrand fece adottare dall’Assemblea Nazionale francese un decreto che istituì un’apposita commissione di illustri uomini di scienza, ai quali fu affidato l’incarico di effettuare gli studi necessari per stabilire l’unità naturale delle misure e dei pesi. Il tutto allo scopo di trovare finalmente quella “giusta”, ovvero facilmente applicabile da tutti, inalterabile e verificabile in ogni momento. Essi ripartirono dunque dal prendere in considerazione le dimensioni della Terra, ma questa volta basandosi non sul suo diametro, bensì sulla lunghezza di un meridiano terrestre.
Nonostante fossero già stati condotti degli studi in merito, la Commissione nutriva ancora qualche dubbio sull’esattezza dei numeri, e per questo scelse di procedere ad una misurazione del meridiano di Parigi, misurandone l’arco compreso fra Dunkerque e Barcellona. L’incarico venne affidato agli astronomi Mechain e Delambre, che terminarono le loro operazioni nel novembre del 1798: il loro risultato rivive nella nostra vita quotidiana con estrema utilità. Gli fu dato il nome di “metro”, e rappresentava la quarantamilionesima parte del meridiano così misurato.
Dal metro derivarono in seguito le misure del volume - la cui unità è il metrocubo, il quale è un cubo di cui ciascuno degli spigoli ha un metro di lunghezza – e le unità di peso, ossia il grammo – il quale rappresenta il peso, nel vuoto, di un centimetro cubo di acqua distillata alla temperatura di 4°C.
Il sistema metrico decimale (che oggi conosciamo sotto il nome di Sistema Interazionale di Unità di Misura, abbreviato nella sigla SI), dopo altri aggiustamenti giunse ad essere imposto obbligatoriamente in Francia dal 1° gennaio 1840. Un evento che fu visto come una futura istituzione internazionale: i promulgatori si ripromettevano di farlo accettare in tutti i paesi del mondo; sarebbe stato, secondo il linguaggio epico della Rivoluzione francese, un sistema di misure "per tutti i popoli, per tutti i tempi", che l’avrebbe fatta passare ancor più alla storia. Nel 1845 i Savoia adottano il sistema anche nel Regno di Sardegna, che di lì a poco tempo sarebbe diventato parte dell'Italia unità. Fu Giovanni Vialardi, Capo Cuoco e Pasticcere di Real Casa Savoia, a redarre il primo ricettario in lingua italiana con ingredienti espressi in grammi e litri.
Photo via Pexels
Scritto da Sara Albano
Laureata in Scienze Gastronomiche , raggiunta la maggiore età sceglie di seguire il cuore trasferendosi a Parma (dopo aver frequentato il liceo linguistico internazionale), conseguendo in seguito alla laurea magistrale un master in Marketing e Management per l’Enogastronomia a Roma e frequentando infine il percorso per pasticceri professionisti presso la Boscolo Etoile Academy a Tuscania. Dopo questa esperienza ha subito inizio il suo lavoro all’interno della variegata realtà di Campoli Azioni Gastronomiche Srl, , dove riesce ad esprimere la propria passione per il mondo dell'enogastronomia e della cultura alimentare in diversi modi, occupandosi di project management in ambito di promozione, eventi e consulenza per la ristorazione a 360°, oltre ad essere referente della comunicazione on e offline di Fabio Campoli e parte del team editoriale della scuola di cucina online Club Academy e della rivista mensile Facile Con Gusto.






































































































































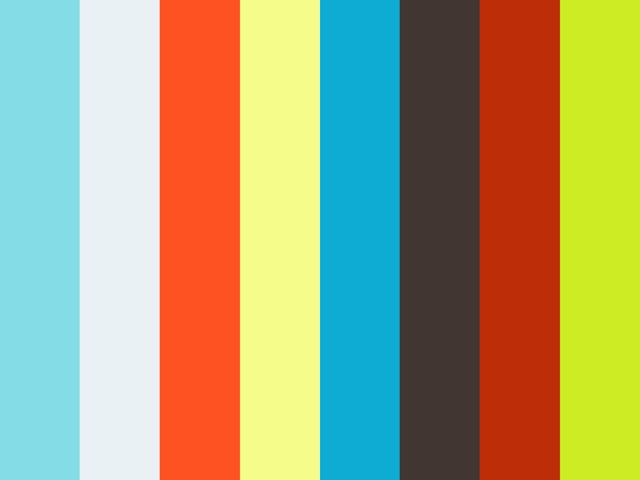
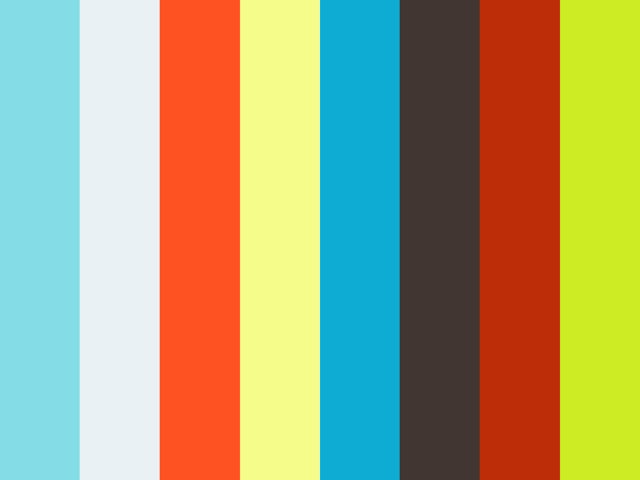
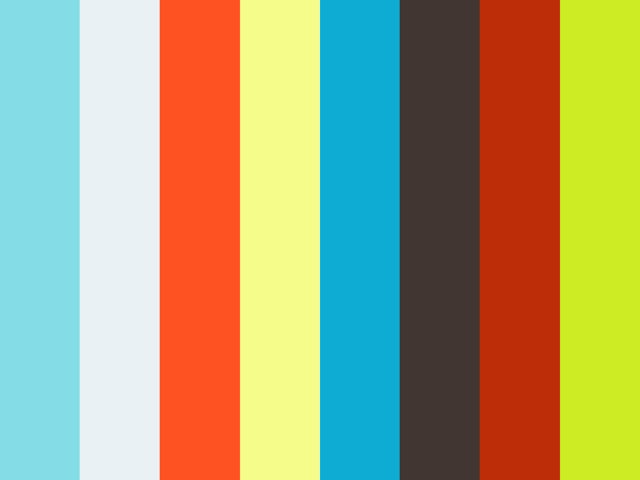
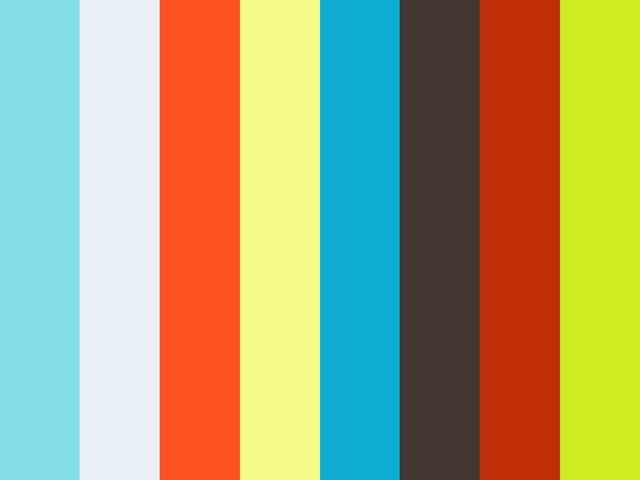
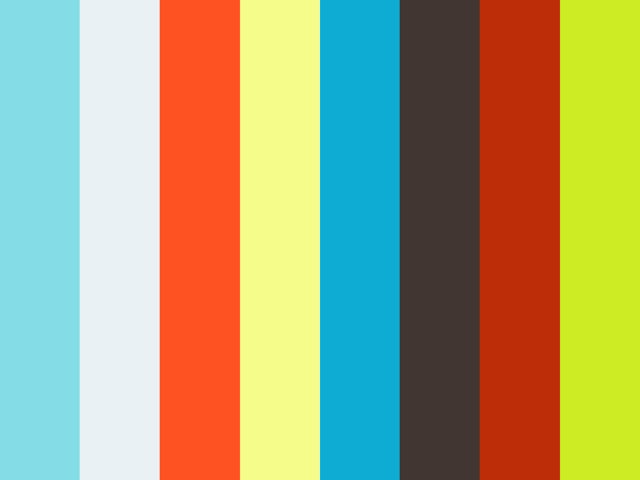
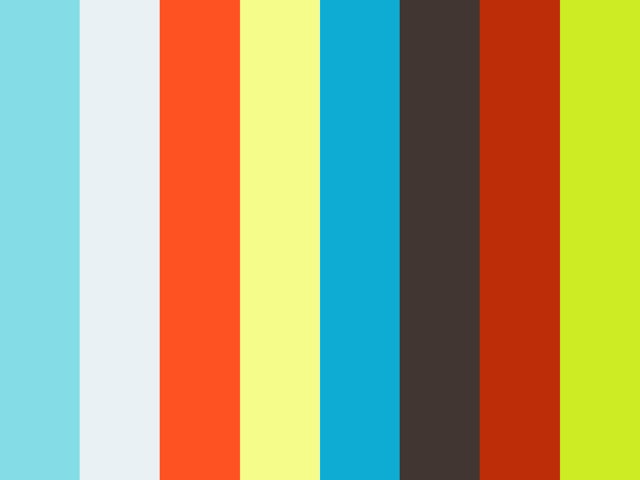

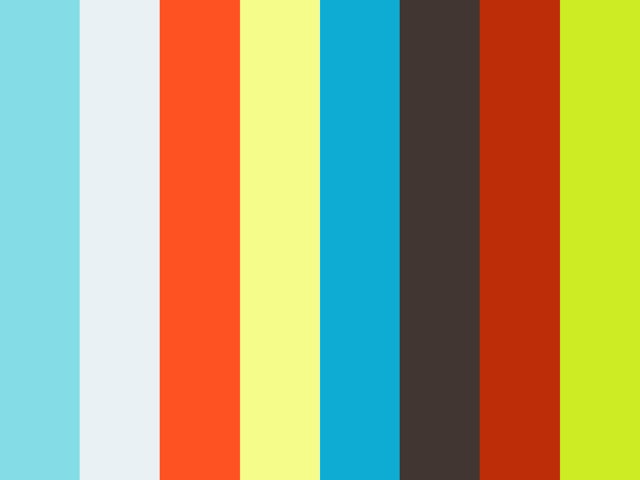

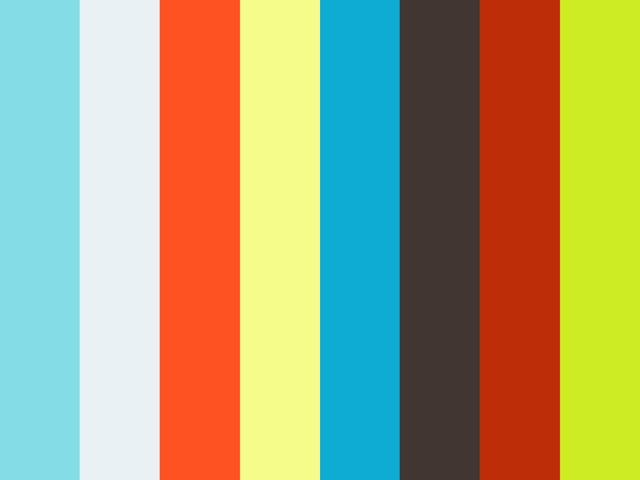
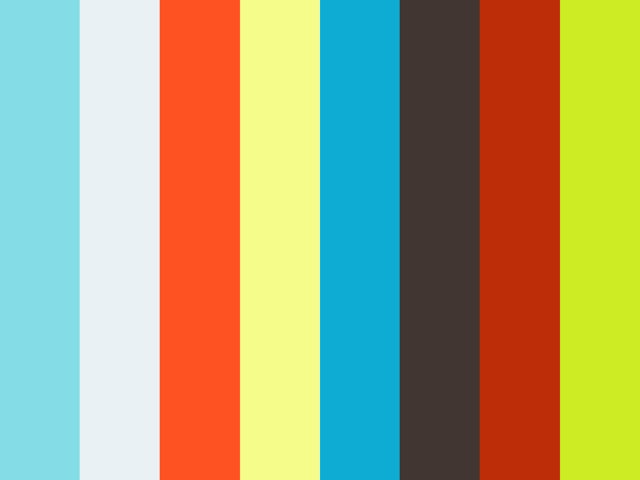
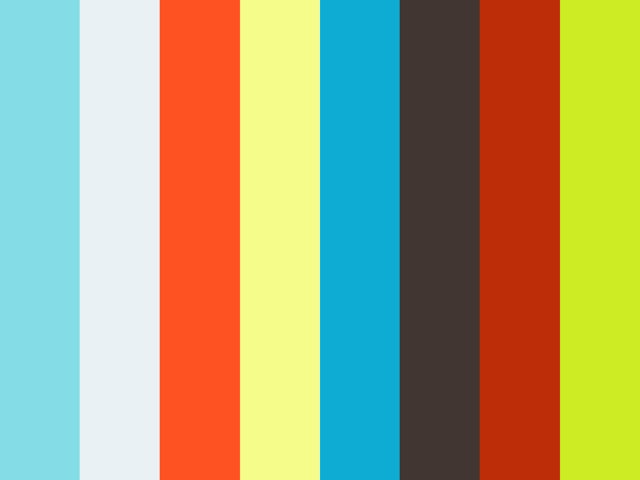
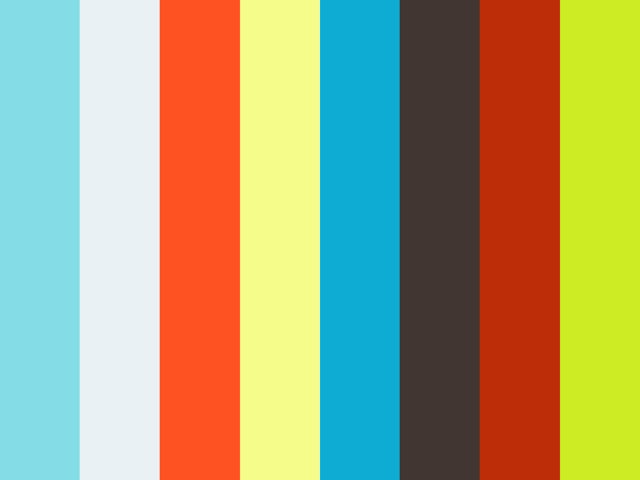
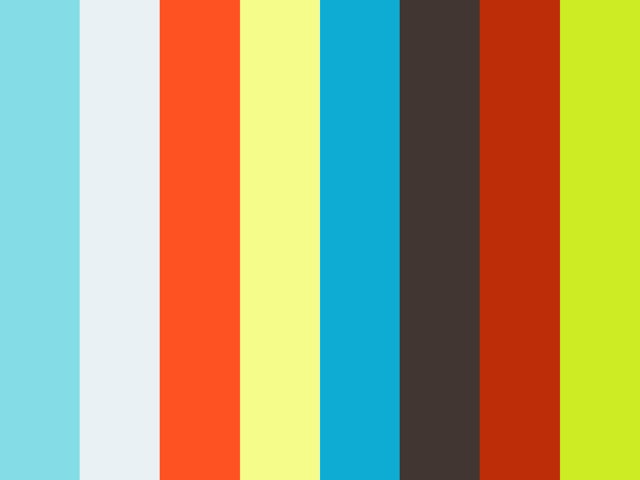
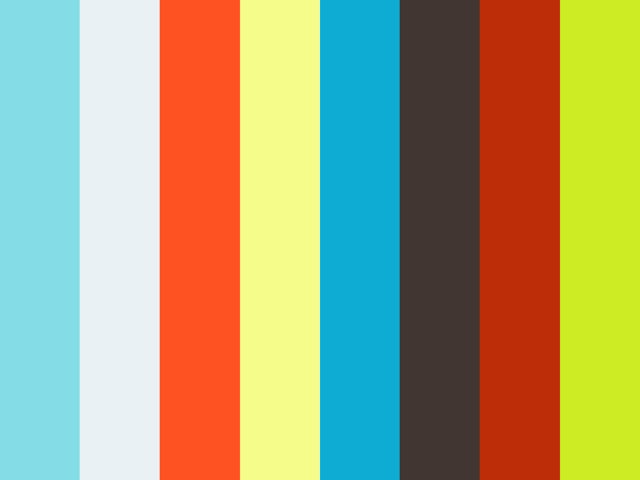
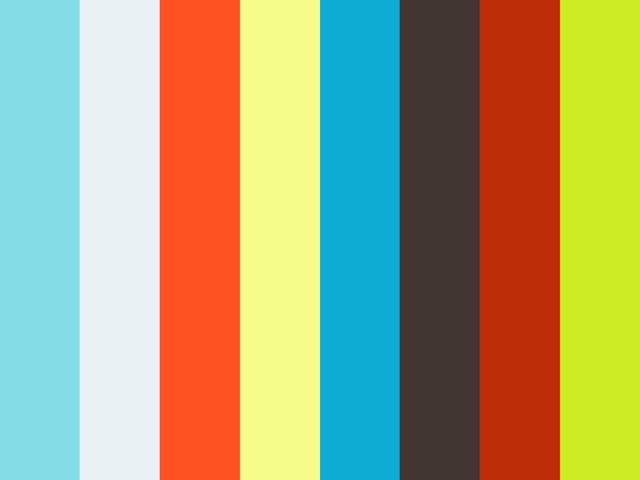
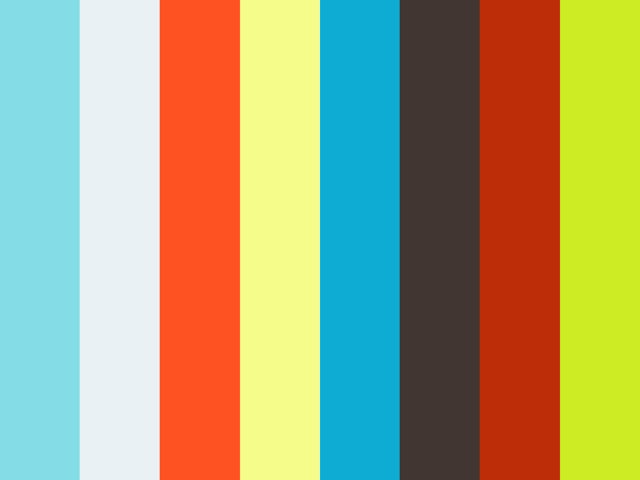






0 Commenti