Esplorando il celebre formaggio a pasta filata simbolo del patrimonio gastronomico meridionale: il re caciocavallo
Alla scoperta della scienza dietro le bevande frizzanti, dai soft drink agli spumanti (e i bicchieri in cui li beviamo)

Le bibite gassate non sono costituite altro che da liquidi in cui è disciolta una gran quantità di anidride carbonica, tenuta sotto pressione. Quando la bottiglia viene aperta, l’uscita del gas riduce la pressione interna, che diventa insufficiente a mantenere in soluzione tutta l’anidride carbonica; questa perciò comincia a lasciare la soluzione attraverso la superficie del liquido, formando bolle.
Nei vini spumantizzati, la sopra citata pressione arriva a sei volte quella normale; cioè, sia il liquido che la sacca di gas sopra di esso sono sottoposti a quella pressione; tra le molecole di diossido di carbonio disciolte nel liquido e quelle in fase di vapore al di sotto del tappo, si stabilisce infatti un equilibrio.
Se si divide il volume di diossido di carbonio gassoso presente in un bicchiere flûte riempito con 100ml di spumante per il volume medio di una bolla si ottiene il numero di bollicine che devono sfuggire dal bicchiere prima che il liquido raggiunga l’equilibrio; così si scopre che sono circa 11 milioni di bollicine!
La formazione delle bollicine si spiega in maniera semplice: lo spumante non è più nel suo stato di equilibrio stabile trovandosi all’aria aperta, il gas perciò fuoriesce dal liquido formando bollicine.
Una volta formatesi, le bollicine crescono perché la pressione del gas nel liquido è maggiore di quella nelle bollicine stesse: il gas perciò diffonde nelle bollicine. Quando queste raggiungono determinate dimensioni la spinta di Archimede supera le forze di adesione e le bollicine si staccano dalle pareti del bicchiere risalendo lentamente in superficie.
L’energia di adesione di una bollicina sul vetro è proporzionale all’area della superficie di contatto tra la bollicina ed il vetro, e questa area dipende dall’energia di superficie. Quando l’energia di superficie è elevata, il liquido bagna bene il vetro e la superficie di contatto è ridotta, la bollicina è sferica e quando il diametro raggiunge alcuni decimi di millimetro si stacca dal vetro. Questo accade nei comuni bicchieri quando sono puliti.
Quando l’energia di superficie è invece debole , cioè quando il liquido bagna male il solido, la bollicina si stacca solo quando è abbastanza grossa (più di un millimetro per le materie plastiche). Ecco perché le bollicine sono piccole nei bicchieri di vetro e grandi in quelli di plastica.
La forma di una bolla è dovuta alla tensione superficiale sulla superficie e dalla resistenza idrodinamica che si oppone al suo moto. Le bolle piccole hanno la superficie molto curva, la tensione superficiale predomina e la bolla assume la forma sferica per minimizzare l’area della superficie. L’energia della bolla è infatti minima se questa ha forma sferica; qualunque deformazione aumenta l’area della superficie e quindi richiede energia aggiuntiva. Le bolle grandi invece hanno minore curvatura, la resistenza idrodinamica è abbastanza rilevante e la scia lasciata dalla bolla durante la salita può appiattirne la superficie inferiore.
In genere una bolla può formarsi e poi crescere soltanto se le sue dimensioni non sono superiori ad un certo valore critico.
Il problema di una bolla più piccola è l’alta curvatura della sua superficie: l’attrazione reciproca delle molecole d’acqua lungo di essa tende a far scoppiare la bolla, nonostante la spinta verso l’esterno esercitata dal gas in essa contenuto. Invece, la superficie di una bolla più grande ha minore curvatura e la forza diretta all’interno esercitata dalle molecole d’acqua lungo la sua superficie non è sufficiente a farla scoppiare.
E’ tuttavia improbabile che le bolle più grandi delle dimensioni critiche si formino nel liquido stesso: non possono infatti apparire all’improvviso già con quelle dimensioni , e le bolle più piccole non possono crescere.
Traiettorie delle bolle - Una bolla che si stacca dalla base di un alto contenitore cilindrico pieno d’acqua dovrebbe salire in linea retta, e in effetti le bolle grandi e piccole si comportano in questo modo. Ma le bolle di dimensioni intermedie seguono un percorso a zigzag o elicoidale.
Se lo spumante o la birra fossero privi di sostanze tensioattive, le bolle potrebbero risalire secondo traiettorie lineari. Le bolle piccole sono sferiche e riescono a risalire in linea retta; quelle che hanno il raggio critico di 3 mm, indipendentemente dal rivestimento tensioattivo, vengono deformate dalla pressione esercitata da parte del liquido sulla loro superficie superiore, assumono una forma ovale e risalgono seguendo traiettorie a zigzag o a spirale.
Le traiettorie irregolari delle bolle si osservano all’interno delle bottiglie di spumante o di birra e non nei bicchieri, dove lo spostamento delle bolle è troppo breve per cui le bolle non raggiungono le dimensioni critiche suddette. Sembra che il moto irregolare delle bolle sia anche dovuto ai vortici che si formano sul lato inferiore di una bolla quando questa si fa strada nell’acqua per risalire; se i vortici si alternano tra destra e sinistra , la bolla può deviare da una parte all’altra.
La formazione dei vortici sembra sia causata da oscillazioni della bolla durante la salita.
Se due bolle si avvicinano mentre salgono il loro moto può essere modificato dal flusso d’acqua fra di esse ; ne deriva che le bolle possono oscillare o separarsi o avvicinarsi fino a “baciarsi” (kissing), secondo la terminologia inglese. Inoltre ,come in una corsa ciclistica , le bolle che sono dietro si possono muovere con velocità maggiori sulla scia di quelle che le precedono nella loro ascesa verso la superficie del liquido.
Il suono delle bolle - Il piacevole suono delle bollicine, che accompagna l’atto di stappare e mescere lo spumante, è il risultato di un processo “ a valanga”. Tale suono è infatti la somma di molti lievi scoppiettii di bolle individuali . Se l’esplosione delle bolle avvenisse in modo costante si sentirebbe un fruscio uniforme, come il disturbo nelle trasmissioni radio. E’ tipico di diversi processi acustici questa specie di “rumore bianco”, nel quale la frequenza del suono è distribuita a caso su un ampio intervallo, mentre l’ampiezza è praticamente costante.
Invece nel caso dello spumante il “fizz” è ben diverso; il suono presenta infatti dei picchi caratteristici.
Le bolle non scoppiano indipendentemente l’una dall’altra, e ciascuna esplosione individuale dura all’incirca 1/1000 di secondo , mentre una numerosa serie di esse si susseguono rapidamente combinandosi per generare il segnale acustico. Il tempo tra esplosioni successive è variabile ed esse non hanno una durata definita, comportandosi come un sistema a molti componenti nel quale l’effetto globale è dovuto ad una grande varietà di interazioni individuali.
Scritto da Elena Stante






































































































































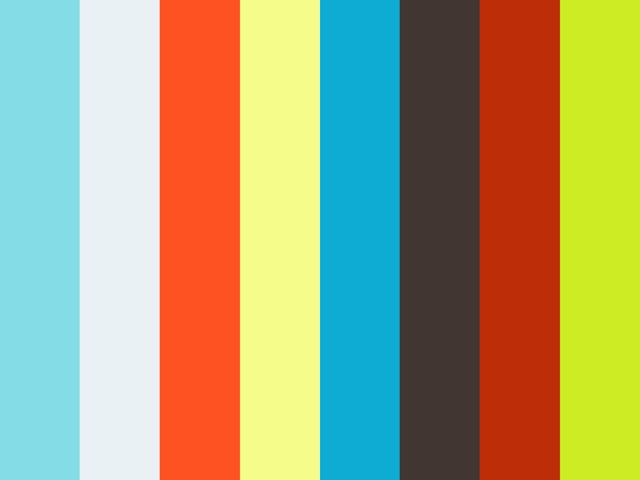
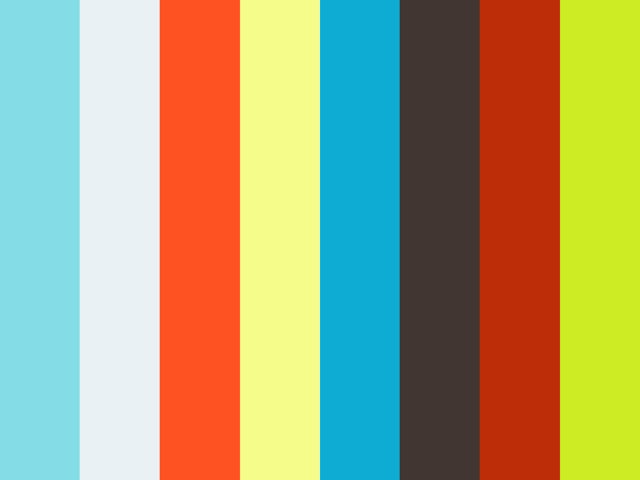
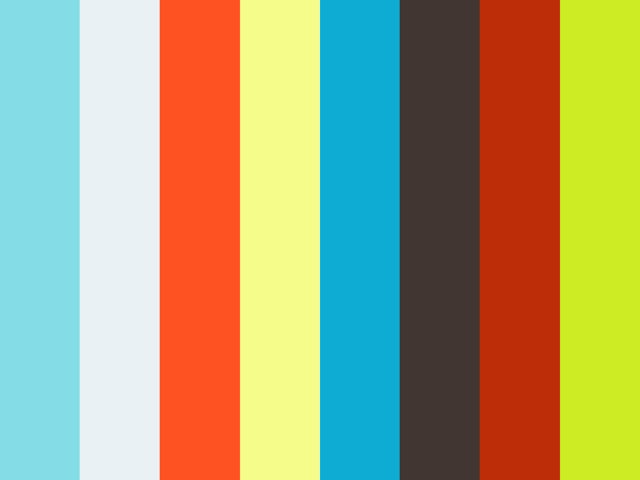
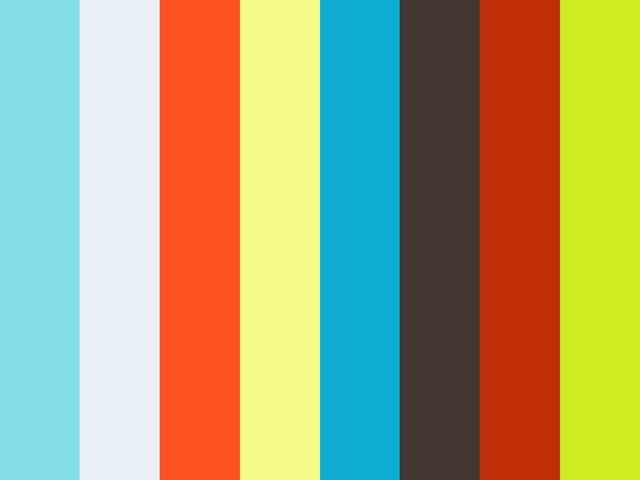
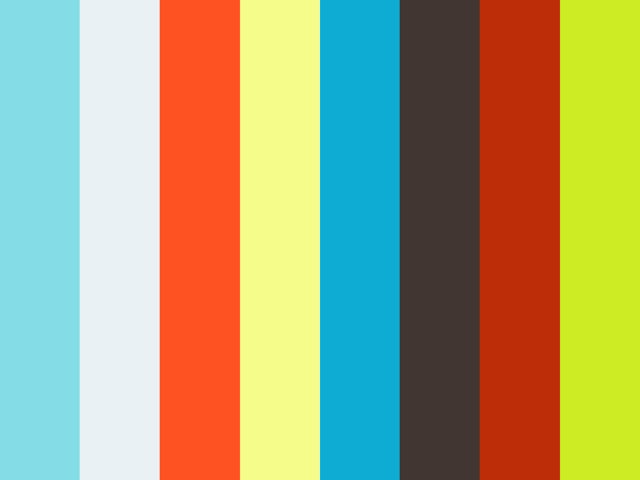
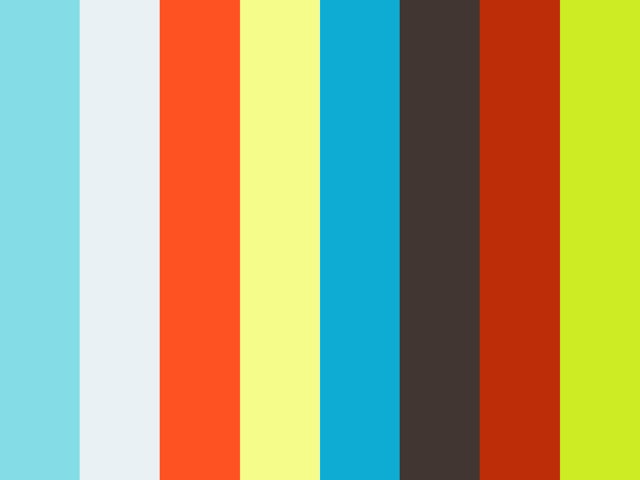

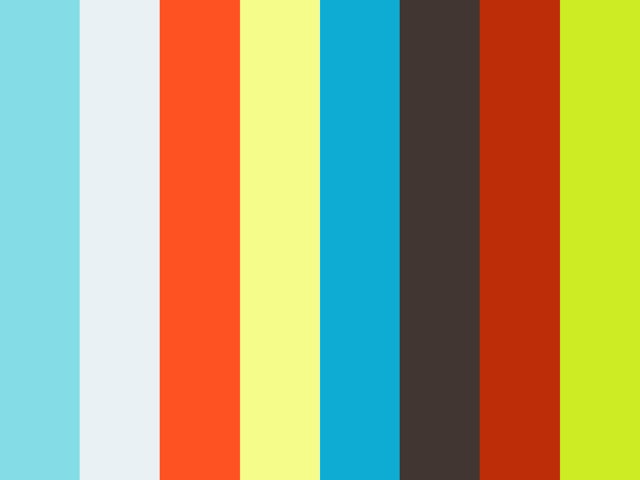

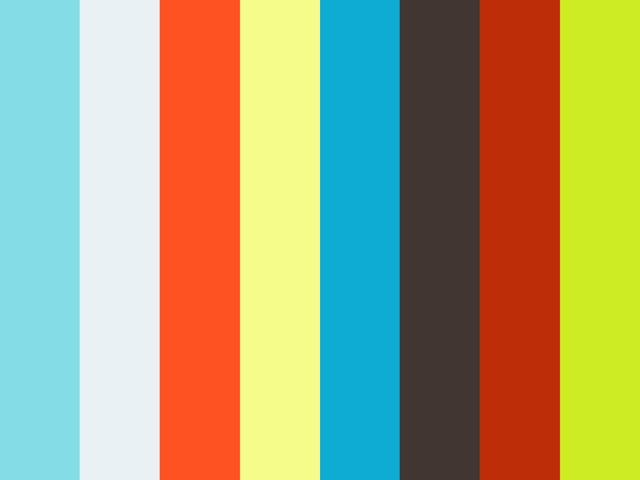
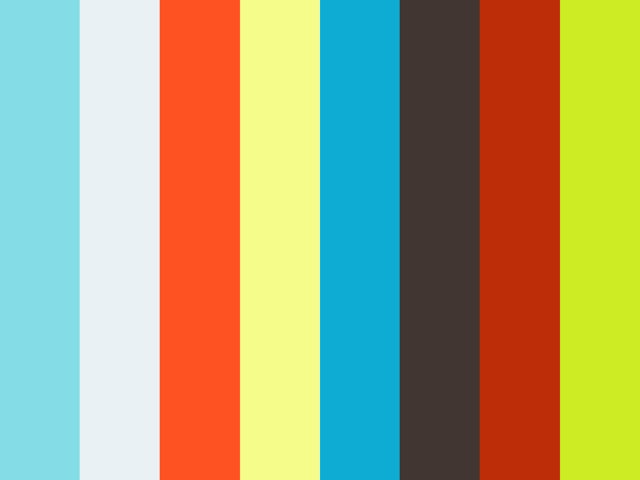
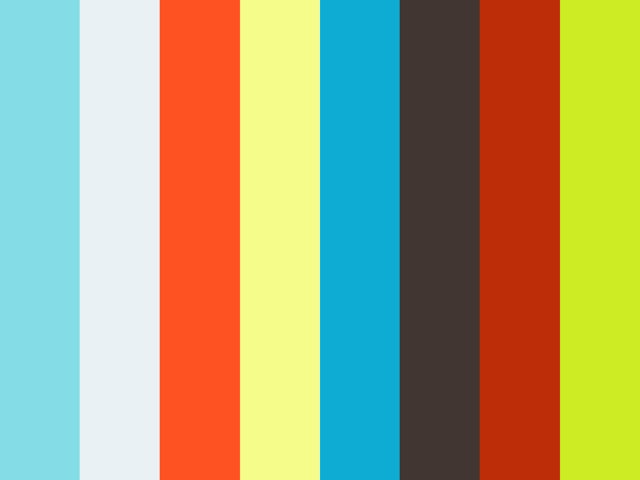
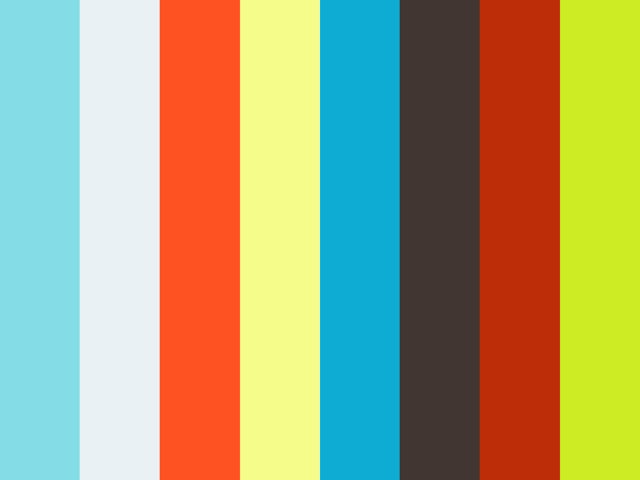
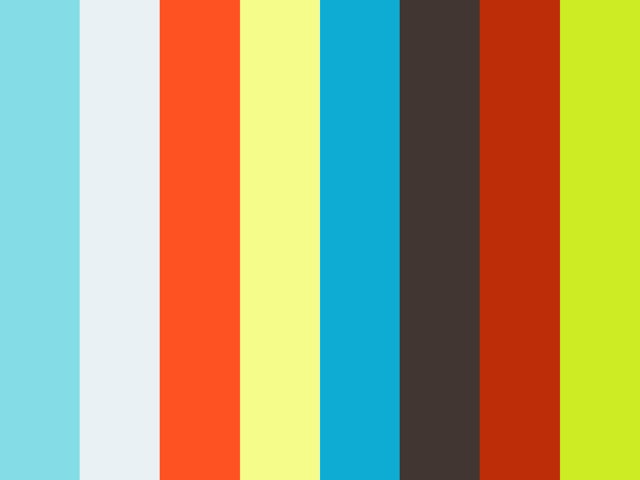
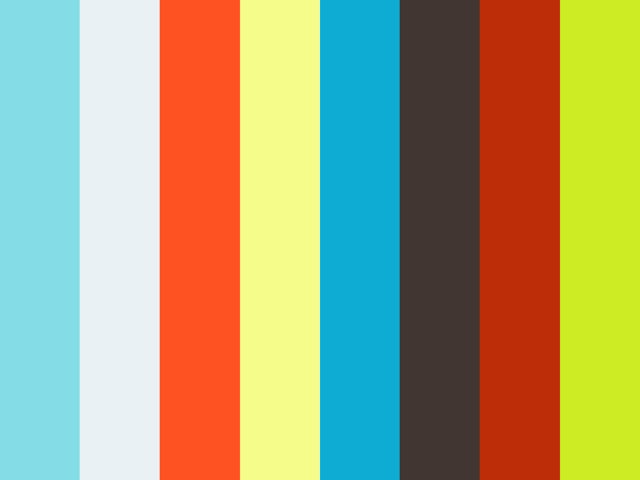
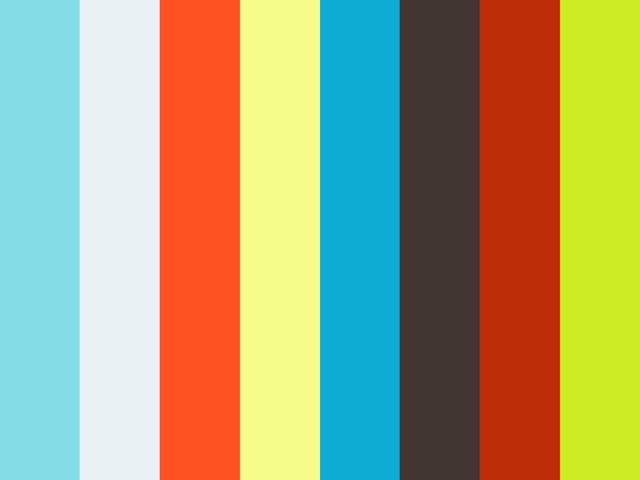
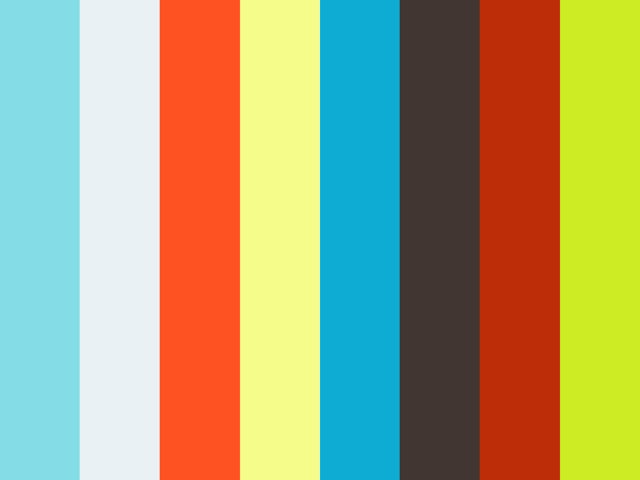






0 Commenti