Lunedì 1 luglio non perdete una sua nuova, stuzzicante ricetta a "Casa Alice Insieme" con Franca Rizzi!
Le ragioni del rifiuto occidentale e la teoria del foraggiamento ottimale

Anche se gli insetti sono stati inseriti nelle liste dei cosiddetti novel food, e anche se l’Unione Europea ha emanato il Regolamento 2283/2015 che regola l’introduzione di tali alimenti sul territorio, è un’evidenza che gli europei – così come gli americani - ad oggi non riescono a nutrirsi di insetti, perché li reputano disgustosi.
In altri continenti però, ci sono delle popolazioni insettivore, per le quali questi animaletti sono altrettanto importanti degli altri per la fonte di proteine e grassi che rappresentano nella loro dieta. Abbiamo cercato allora di indagare sulle motivazioni di questo “rifiuto occidentale”.In California, prima che vi giungessero gli europei, gli indigeni avevano a disposizione solo carne di cane e mangiavano regolarmente insetti per sopravvivere.
Nel bacino del Rio delle Amazzoni, tra Brasile e Colombia, il consumo di larve d’insetti è del tutto normale, e anche la Cina è uno dei paesi che non disdegna affatto di mangiare insetti, specialmente bachi da seta. La fame di carne veniva quindi colmata mangiando insetti, perché questi sono fonte di buoni nutrienti e quindi di energia. Anche nel Sud est Asiatico, nei Caraibi, in Madagascar e nel resto dell’Africa sono consumati insetti di vario genere, sia nelle forme larvali che adulte, sia alate che attere, oltre a ragni come le tarantole e gli scorpioni, oltre a uova di scarafaggio fritte.
Si può già affermare, quindi, che questi animaletti sono graditi e commestibili perché salvavano e salvano dalla carenza di carne, cioè di proteine. E se avessero veramente avuto un sapore “disgustoso”, sicuramente nessuno avrebbe mai pensato di mangiarli.
Si dice che al gusto gli insetti ricordino i vegetali, come la lattuga e la patata, altri invece i formaggi tipo gorgonzola; spesso alla pietanza di insetti si uniscono peperoncini, sale, riso, curry e altri odori e spezie. Gli occidentali che hanno mangiato e descritto il gusto degli insetti, non hanno mai accusato problemi per la salute. Anche perché, a dire degli studiosi, effettivamente gli europei un tempo mangiavano insetti.
Aristotele cita la prelibatezza delle cicale, Aristofane esalta le cavallette, Plinio il Vecchio conferma che ai Romani piaceva il cossus (un insetto farfalla che attacca il legno di molte piante, oltre ai frutti), e nel medioevo i Germani mangiavano maggiolini e bachi da seta.
Nei secoli successivi si è cercato, senza successo, di convincere i popoli anglosassoni e francesi della convenienza a consumare insetti, considerandone soprattutto il basso prezzo e l’utilità per sfamare i più poveri. Il tentativo però non ebbe successo: gli europei continuano ancora oggi a essere disgustati dagli insetti. Se si valutano gli aspetti nutrizionali della questione, questi propenderebbero assolutamente per il consumo degli insetti, in quanto sono perfettamente paragonabili alle carni rosse, infatti:
- 100 g di termiti= 610 kcal + 38 g proteine + 46 g di grassi
- 100 g di larve di falena= 375 kcal + 46 g di proteine + 10 g di grassi
- 100 g di mosche domestiche= 63 g di proteine + 15 g di grassi
- 100 grammi di hamburger= 245 Kcal + 21 g di proteine + 17 g di grassi
Dal punto di vista proteico ed energetico, quindi, gli insetti sono più convenienti anche di gamberetti, granchi, aragoste (proteine nobili ma pochi lipidi), cozze, ostriche, altri bivalvi (poche calorie e pochi lipidi). L’aspetto negativo degli insetti è rappresentato dal rivestimento di chitina, proteina indigeribile per l’uomo. Ma non può essere la chitina il motivo del rifiuto, visto che anche tanti crostacei preferiti hanno la chitina e chi li mangia la elimina.
La motivazione ufficiale del rifiuto di mangiare insetti da parte di euroamericani è che questi animaletti trasmettono agenti di terribili malattie. Questo però non è plausibile perché anche le altre carni contengono germi di malattie, solo che noi non mangiamo la carne cruda ma cotta. E anche rispetto a quanto abbiamo detto prima, emerge che gli insetti non vengono mangiati crudi, ma cotti in diverse maniere.
Per il rifiuto degli insetti non vale nemmeno la motivazione insetto = sporcizia = malattia perché cosa dire allora di ciò che proviene dai campi coltivati, dove si concima con il letame? Se la motivazione fosse questa saremmo già morti di fame perché avremmo dovuto rifiutare tanti vegetali, i quali invece vengono regolarmente consumati.
L’ultimo aspetto, allora, che resta da esaminare per spiegarci questo rifiuto di insetti a tavola sta nella ricerca del rapporto costi/benefici correlato all’alimentazione insettivora. In effetti, il rifiuto discende proprio da tale rapporto in quanto pur essendo gli insetti numerosissimi in natura, quindi abbondanti, pur essendo ricchi di proteine e grassi e calorie, sono però la fonte meno vantaggiosa di carne in termini di costi/benefici.
Questo ci spiega non solo perché in alcune zone non si mangiano insetti, ma anche perché, laddove si mangiano, se ne mangiano solo alcuni tipi e talora in forme non adulte. Per spiegare tutto con razionalità, gli studiosi hanno formulato la teoria del foraggiamento ottimale: secondo questa teoria, tutti gli animali (uomo compreso) che vanno a caccia per poter mangiare, non mangiano tutto ciò che incontrano sulla loro strada e che potenzialmente potrebbero (in base alla propria specifica fisiologia di specie), ma solo quelle prede che rappresentano un vantaggio calorico.
Ovviamente, è un istinto naturale che porta a tale valutazione, non un ragionamento preciso. In sostanza, il cacciatore (uomo o animale) deve massimizzare il ricavo calorico, cioè il rapporto tra calorie fornite dalla preda catturata e tempo impiegato per il ritrovamento e la cattura. Se ne deduce che, se la ricerca di una preda con alto contenuto calorico dovesse comportare lunghi tempi di lavoro totale, il ricavo calorico si abbassa. Diventa allora conveniente inserire nella dieta prede con poche o molte calorie, ma numerose e facili da prendere.
Ecco spiegata la preferenza dei popoli europei e americani per la carne trovata dal macellaio o direttamente in un allevamento: il ricavo calorico è sempre positivo, in quanto le calorie della preda acquistata sono notevoli e la fatica applicata all’acquisto della preda è minima.
Note bibliografiche e sitografiche
- M. Harris, Buono da mangiare, Ed. Einaudi
- J. Diamond, Collasso, Ed. Einaudi
- J. Moussaieff, Chi c’è nel tuo piatto?, Ed. Cairo
Photo via Canva








































































































































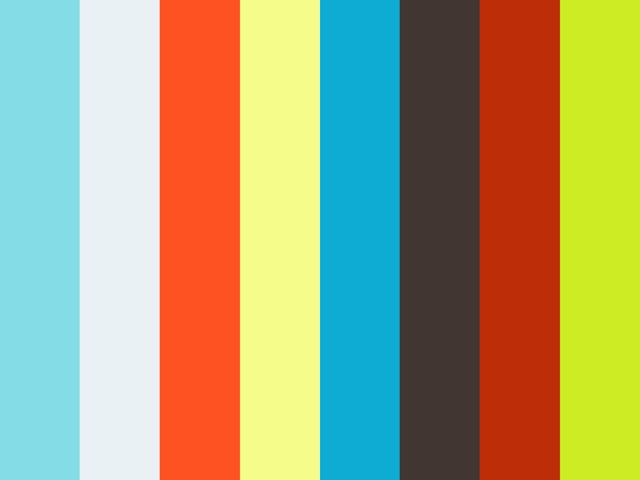
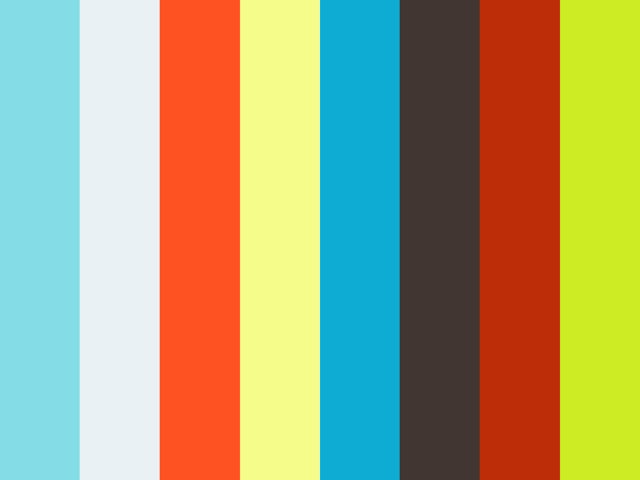
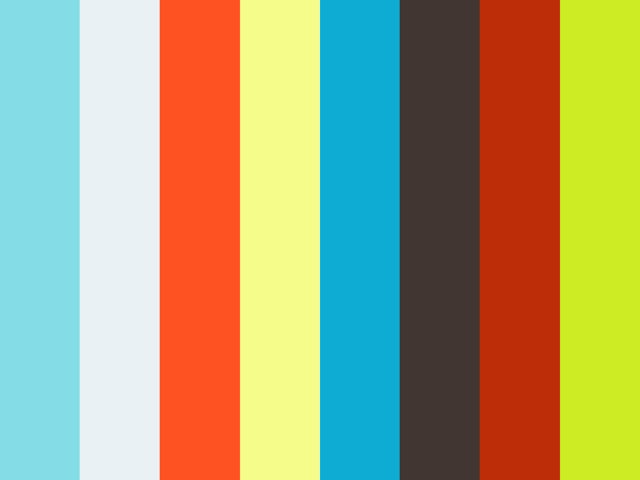
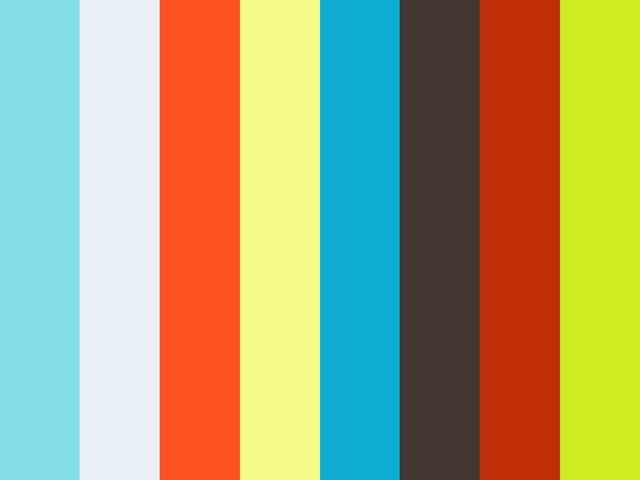
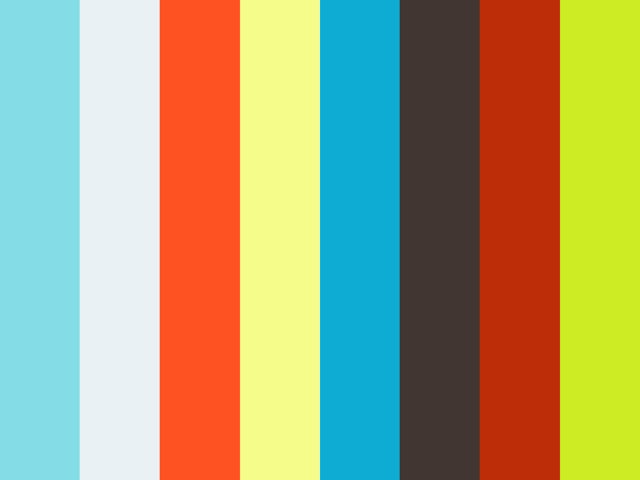
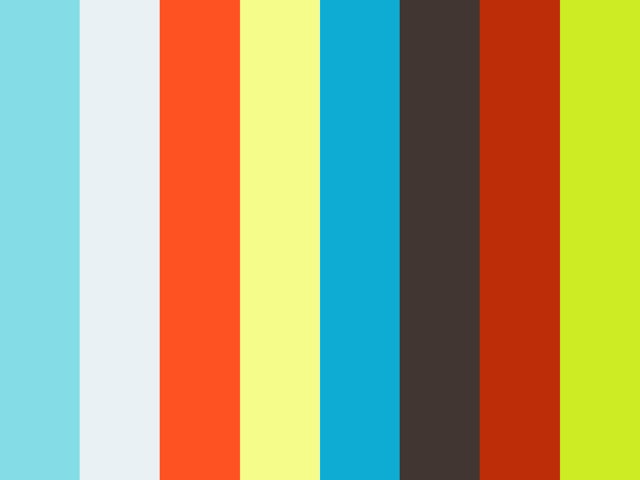

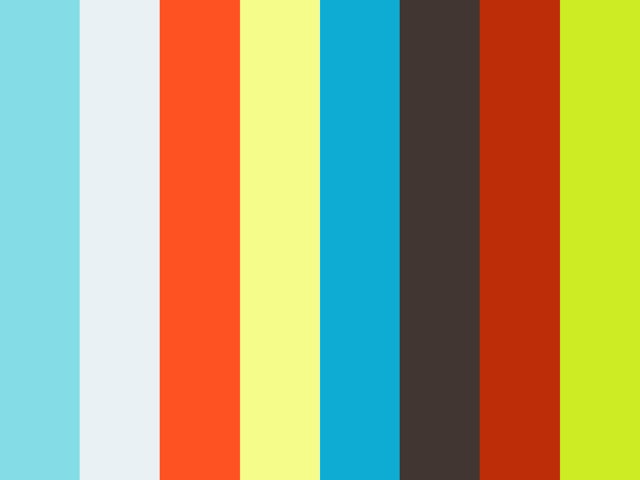

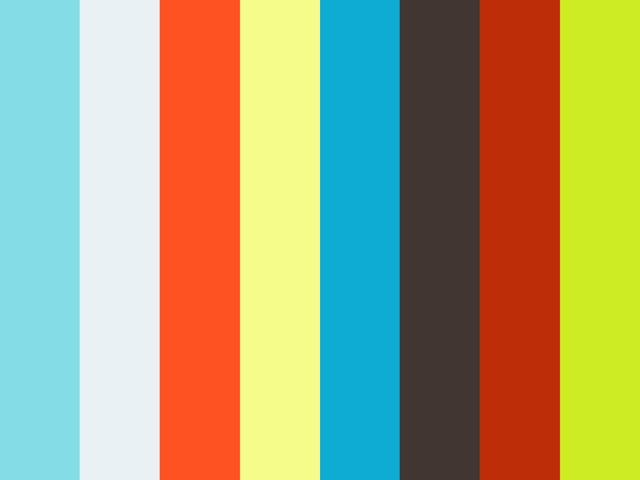
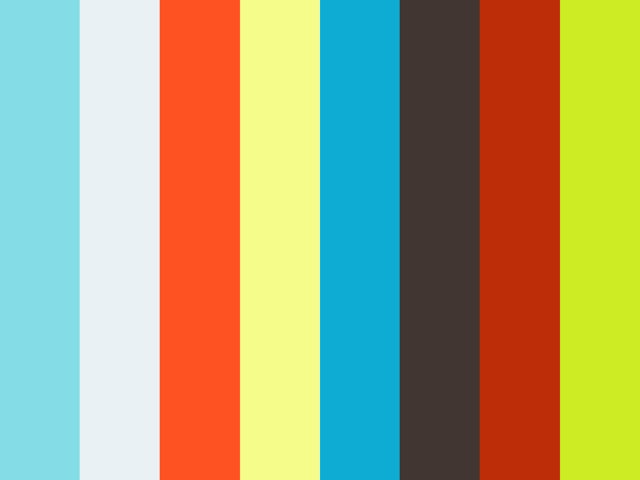
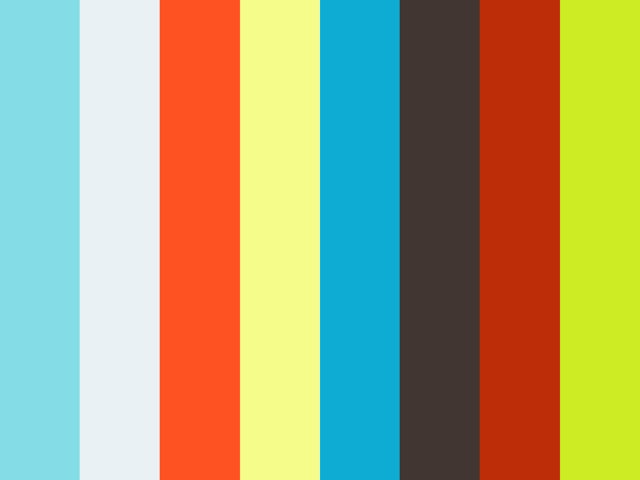
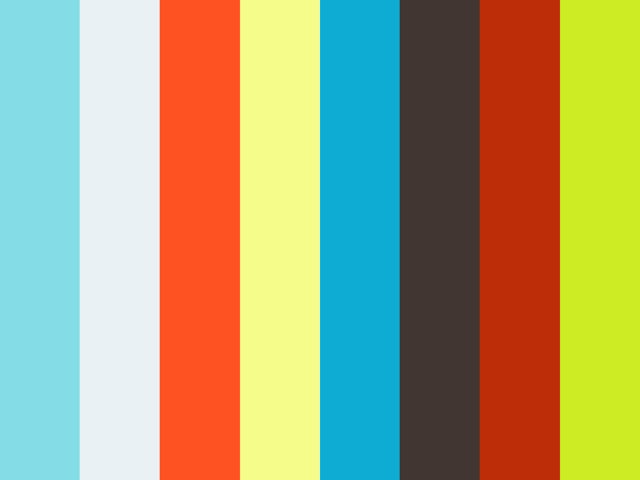
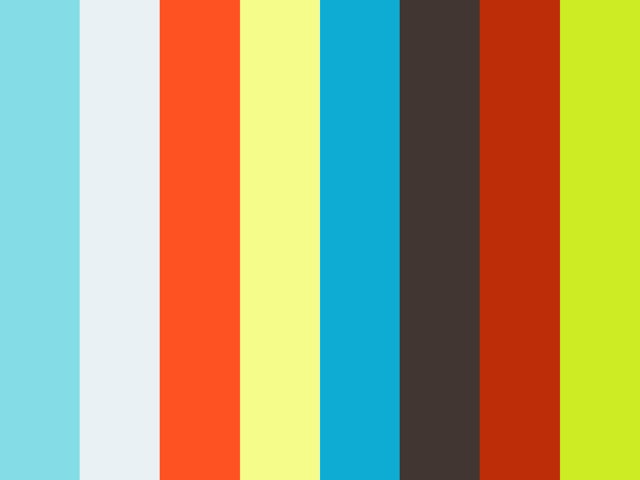
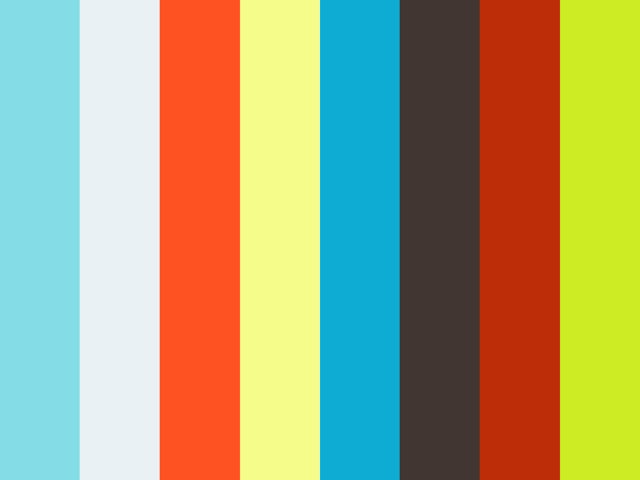
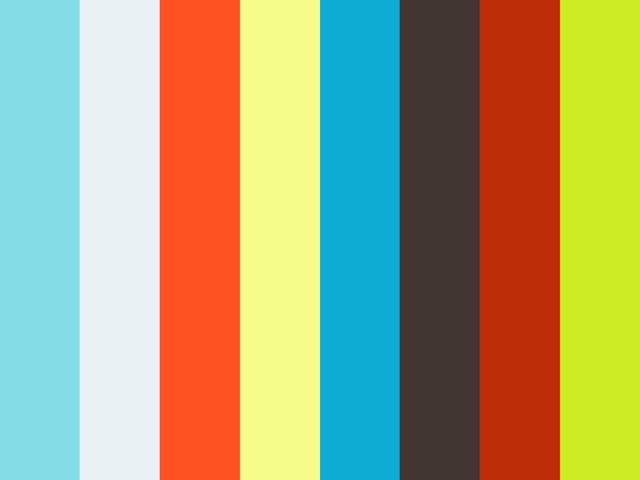
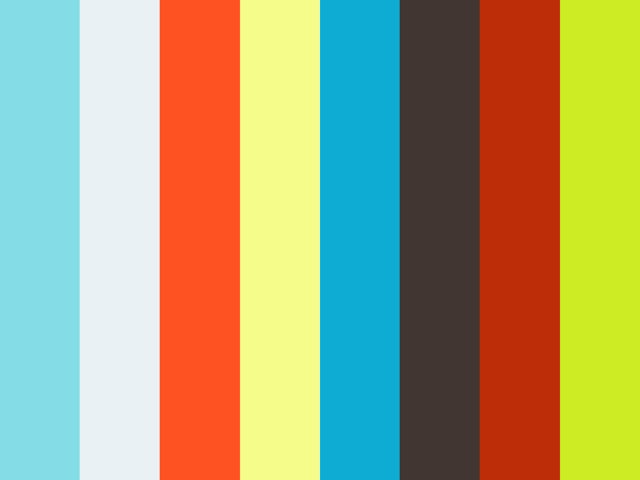





0 Commenti