E’ finalmente nata un’app gratuita per donare il cibo in eccedenza
Il fluido non newtoniano più sorprendente in cucina (e non solo)

Come ben sappiamo, la caratteristica di tutti i fluidi è la capacità delle loro particelle di “scorrere” le une sulle altre. Non a caso, la parola “fluido” deriva dal latino fluére, che significa appunto “scorrere”.
Una caratteristica dei fluidi newtoniani è la viscosità, che rallenta lo scorrimento di queste particelle di un liquido; ne è un tipico esempio il miele che scorre molto più lentamente rispetto all'acqua. Nel fluidi newtoniani maggiore è la viscosità, maggiore sarà la forza da applicare. Un fluido non newtoniano è invece un fluido la cui viscosità non ha un valore determinato, in quanto cambia al variare del tipo di forza ad esso applicata.
I fluidi non newtoniani possono mostrarsi stupefacenti all’osservazione. Un esempio si trova anche in cucina, nascosto nel bianco amido di mais: mescolandolo con un po’ d’acqua e agitando il miscuglio con un cucchiaio lentamente, esso resterà liquido; invece mescolando più velocemente oppure rovesciando rapidamente il recipiente, il fluido tenderà a comportarsi come una massa solida.
In parole povere, un fluido non newtoniano si comporta quasi come un solido se viene sottoposto ad una forza improvvisa, mentre conserva le caratteristiche di un liquido (molto viscoso) se la forza è regolare e continua.
L'amido di mais è una polvere bianca che si ottiene dalla lavorazione del granturco. Il principale utilizzo dell'amido di mais è quello gastronomico: essa è usata infatti per preparare alimenti senza glutine (in sostituzione della classica farina) perché le persone intolleranti al glutine non sono intolleranti alle proteine del mais, ma anche come addensante per moltissime preparazioni cremose.
Oltre al suo più frequente uso in cucina, dopo alcuni trattamenti speciali, l’amido di mais viene adoperato anche in cosmetica, ad esempio nelle creme per le mani con effetti ammorbidenti e nelle maschere sbiancanti per la pelle. Ma l'amido di mais lo troviamo ancora in altri campi: serve a migliorare l'impasto nella produzione della carta, è tra gli ingredienti di alcuni farmaci, è utile nella produzione di sapone, come lubrificante e per la produzione di birra (in parziale sostituzione del più tradizionale orzo, dato il suo costo minore).
Ma l’aspetto più divertente starà nel verificare voi stessi le proprietà quasi magiche di questo prodotto!
Organizzate un piccolo esperimento casalingo, procurandovi una scatola di amido di mais, un recipiente, due bicchieri d’acqua tiepida e un cucchiaio. Versate un po’ dell’amido di mais nel recipiente, fino ad ottenere una montagnola. Aggiungete pian piano l’acqua tiepida e mescolate lentamente; gli amidi normalmente sono sostanze molto igroscopiche, perciò assorbiranno velocemente l’acqua.
Non appena otterrete una “pastella”, potrete aggiungere un’altra quantità di amido uguale alla precedente. Giunti a questo punto, dovrete testare il risultato ottenuto, con un metodo molto semplice. Provate a tirare un pugno bello forte sulla sua superficie: se il liquido schizza avete messo troppa acqua, se invece resta nel recipiente senza neanche macchiarvi le mani, allora avrete dosato bene gli ingredienti.
La percentuale corretta per generare l’effetto dovrebbe essere pari a circa 34% di acqua e 66% di amido. Se lasciate riposare l’impasto, poiché si tratta di una sospensione, dopo qualche ora l’amido si depositerà sul fondo e l’acqua resterà nella parte superiore. Basterà però rimescolare per conferire nuovamente al fluido le proprietà di cui godeva in precedenza.
Ma proviamo a capire e approfondire meglio il fenomeno. Mescolato con acqua il miscuglio presenta le caratteristiche di un fluido non newtoniano,ovvero quella di non avere una viscosità definita. Le grandezze fisiche che caratterizzano e differenziano i fluidi sono: la comprimibilità, la densità e la viscosità.
La comprimibilità indica la variazione di volume, a temperatura costante, dell'unità di volume di un fluido sottoposto ad una pressione unitaria. Rispetto ai gas, i liquidi sono assai poco comprimibili. La densità indica il rapporto tra la massa e il volume e varia in funzione della pressione e della temperatura; essa varia di molto nei gas e poco nel liquidi.
La resistenza che contrasta lo spostamento di particelle vicine rappresenta infine la viscosità o attrito interno del liquido, ovvero la limitazione alla libertà di movimento delle particelle che costituiscono i fluidi. La viscosità varia al variare della temperatura alla quale si trova il fluido, ed essa è piccola nei gas e piuttosto grande nei liquidi.
Si consideri una massa liquida in quiete e la si pensi formata da tanti strati orizzontali paralleli. Come analogia potremmo pensare ad un mazzo di carte da gioco. Applicando una forza alla prima carta, questa comincia a muoversi con una certa velocità. La carta immediatamente sotto viene trascinata con una velocità leggermente più bassa, perché frenata dalla carta immediatamente inferiore e, a sua volta, trascina la terza carta, che si muove con velocità ancora inferiore e così di seguito per tutte le altre.
I fluidi newtoniani sono fluidi che presentano una forza resistente allo scorrimento indipendente dal modo con cui si sollecita il sistema, ovvero il valore della viscosità rimane costante al variare dell’intensità della forza applicata o del tempo in cui questa forza è applicata: si tratta di fluidi che continuano a scorrere indipendentemente dalla forza che agisce su di essi.
Prendiamo ad esempio l’acqua: se la si versa in un recipiente e la si fa ruotare velocemente con un cucchiaio, la sua resistenza non varierà all’aumentare della velocità con cui girate. Esempi di fluidi newtoniani sono tutte le sostanze ad elevata percentuale di acqua, dunque la maggior parte delle bevande classiche (dal tè, al latte, al caffè ecc.). Ma in realtà sono molto numerosi anche i fluidi non newtoniani, cioè i liquidi che variano il valore della loro viscosità al variare della forza applicata e del tempo di applicazione della forza.
I fluidi puramente viscosi, il cui comportamento cambia con l’intensità della forza applicata, si suddividono in pseudoplastici nei quali la viscosità diminuisce al crescere della forza applicata (come ad esempio i succhi e le puree di frutta, i vegetali concentrati, la crema di latte); seguono i dilatanti, nei quali la viscosità aumenta al crescere della forza applicata (come ad esempio le sospensioni di amido e gomma arabica); infine vi sono i plastici, che hanno bisogno di uno sforzo iniziale di taglio allo scorrimento perché il sistema ha una struttura resistente per cui, per poterli mettere in moto, richiedono l'applicazione di una forza tale da far collassate la struttura (come ad esempio il cioccolato fuso fondente o al latte, il ketchup, la mostarda ed i concentrati proteici di soia).
Tra i fluidi con viscosità dipendente dal tempo ricordiamo invece succhi concentrati vegetali o di frutta torbidi, mieli grezzi, latte condensato zuccherato, maionese, albume d’uovo e crema pasticcera.
Scritto da Elena Stante






































































































































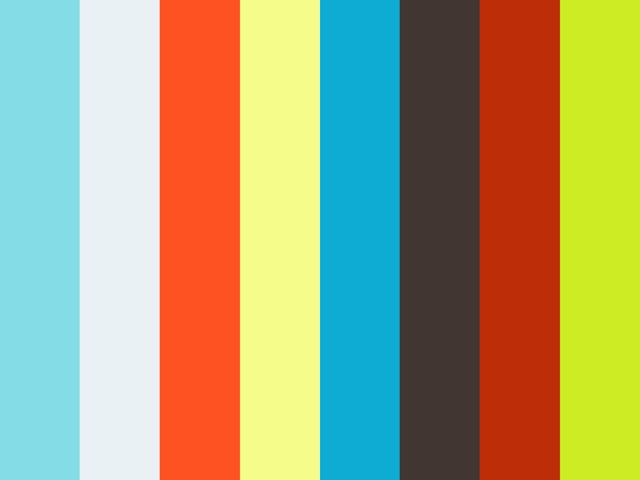
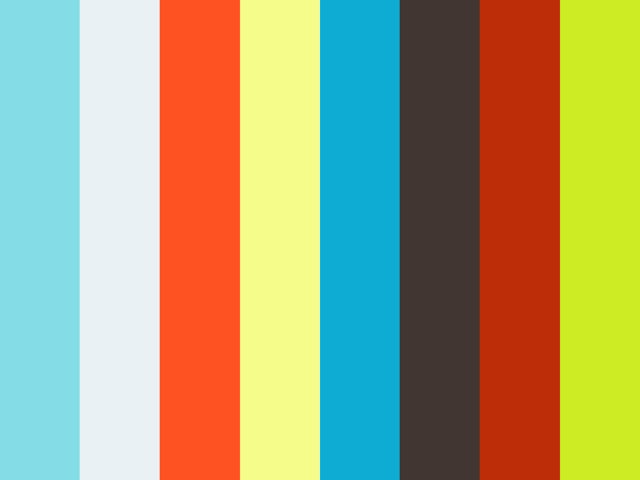
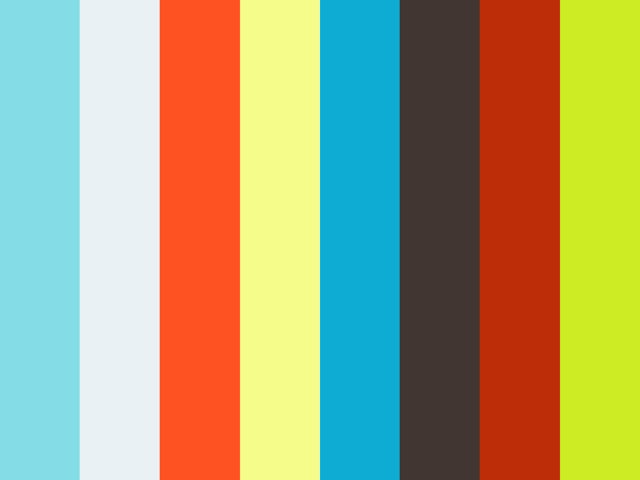
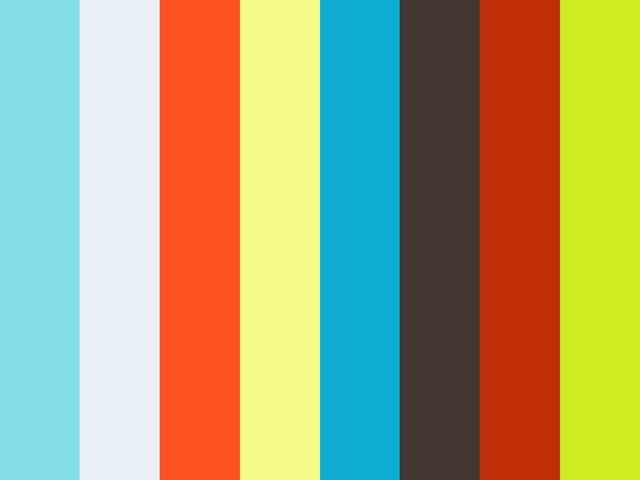
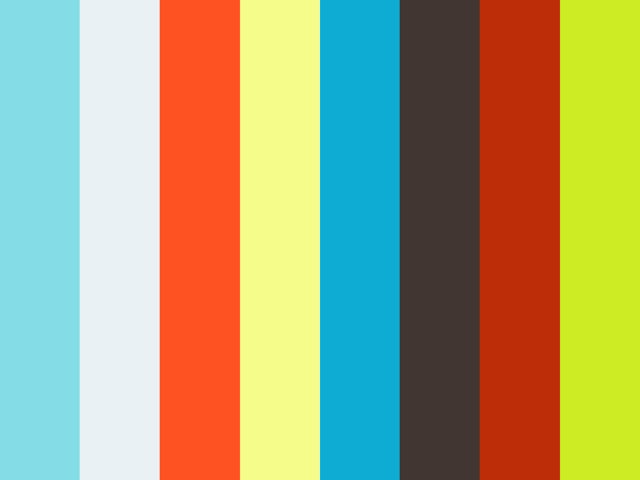
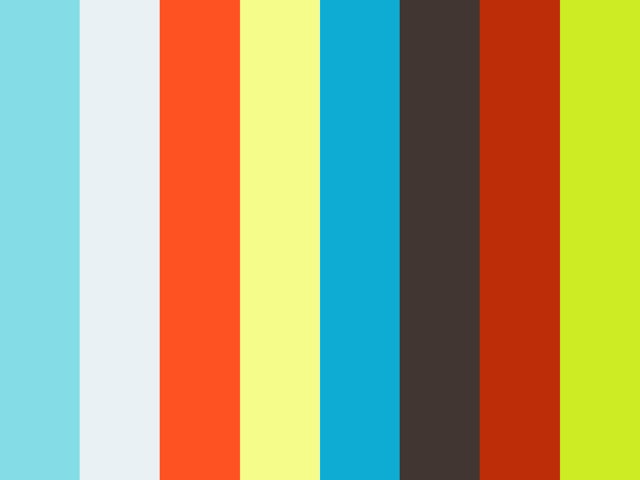

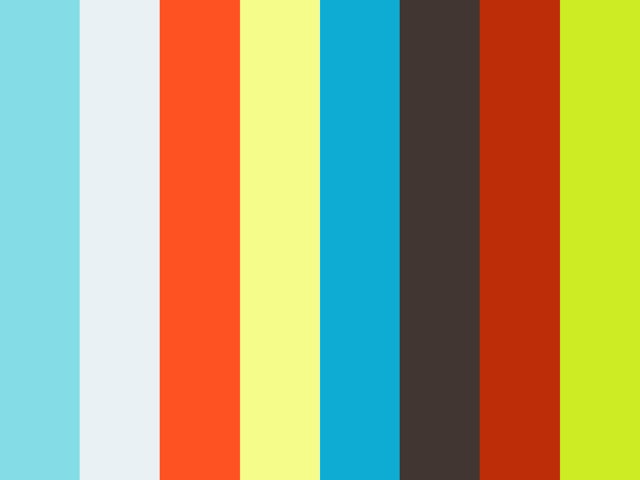

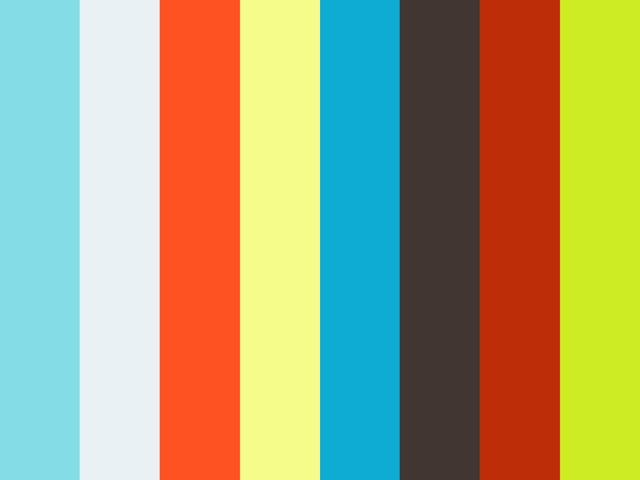
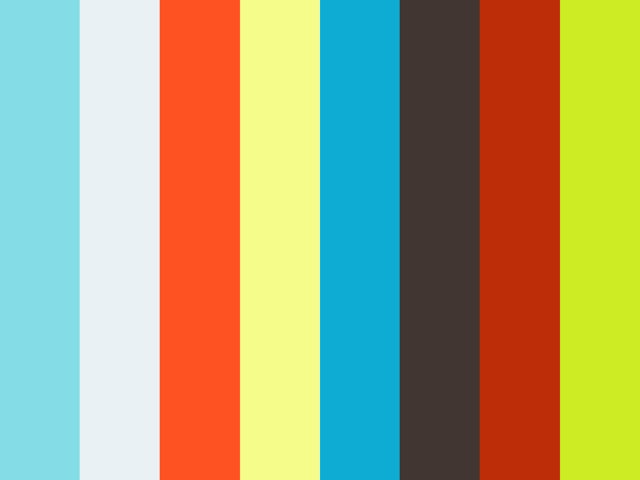
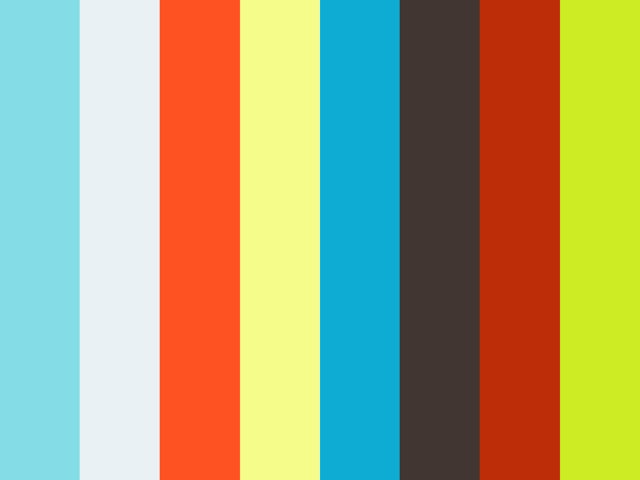
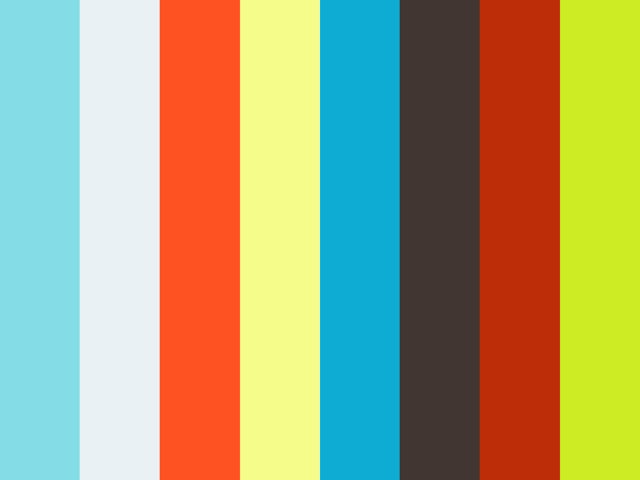
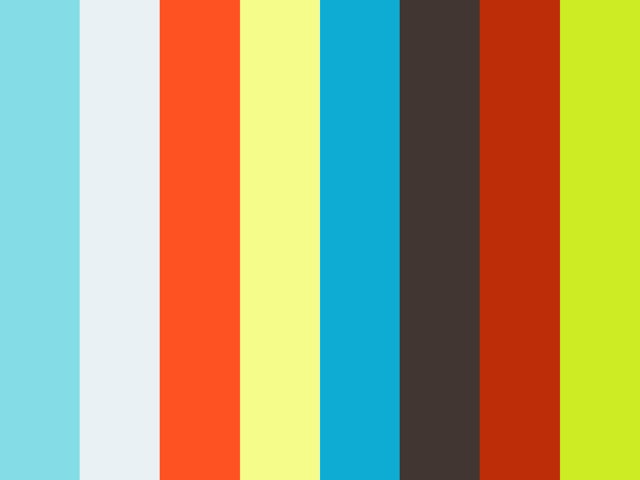
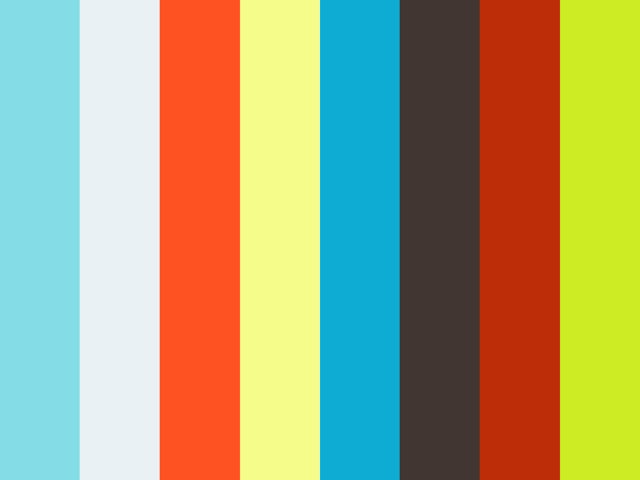
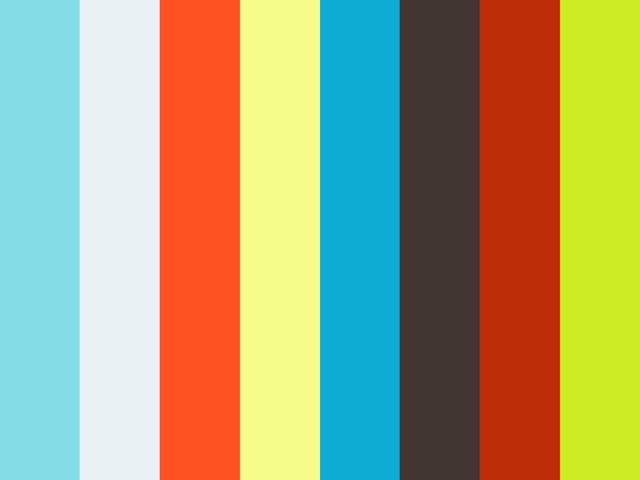
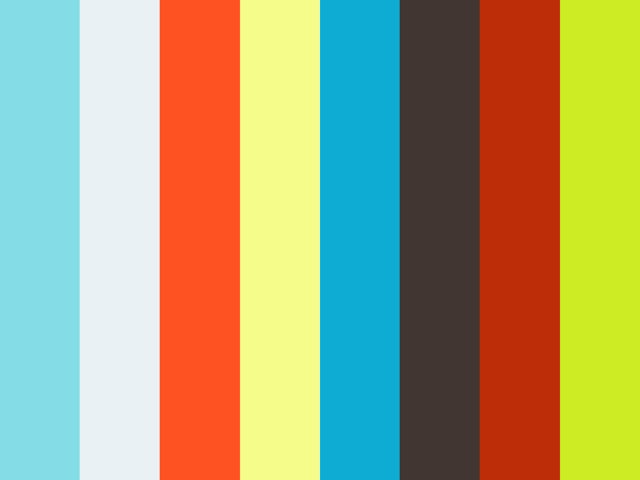






0 Commenti